LOGIN UTENTE
Registrati a MelodicRock.it

Registrati gratuitamente a Melodicrock.it! Potrai commentare le news e le recensioni, metterti in contatto con gli altri utenti del sito e sfruttare tutte le potenzialità della tua area personale.
effettua il Login con il tuo utente e password oppure registrati al sito di Melodic Rock Italia!
Ultime Recensioni
- Home
- /
- Ultime Recensioni
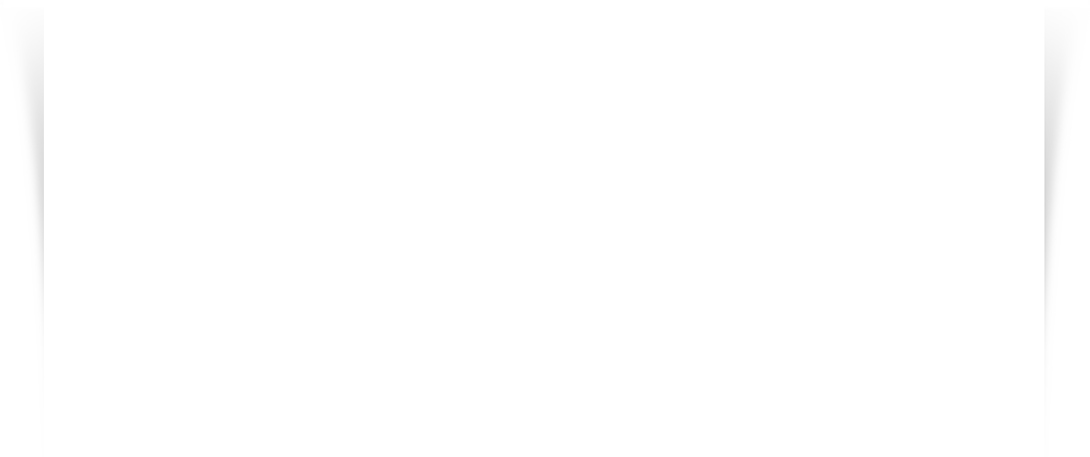
Stoneflower – Finally – Recensione
13 Gennaio 2021 4 Commenti Vittorio Mortara
genere: Aor
anno: 2020
etichetta: Aor Heaven
La band norvegese, capitanata dal talentuoso chitarrista Tom Sennerud, arriva con questo “Finally” al traguardo del terzo album. Il debutto “Destination Anyware” e il successivo “Crank a little smile” sono due buoni platter di AOR in stile scandinavo che dimostrano un discreto stile compositivo, nonché un’ottima padronanza degli strumenti.
Oggi, al fianco di Tom, troviamo la sezione ritmica costituita dai fratelli Huneide. Alle lead vocals è stato scritturato il dotatissimo cantante John Masaki, vincitore del talent show “Idol Norway”, analogamente a quanto fecero gli H.E.A.T. quando presero Erik Gronwall dalla versione svedese dello stesso show. Su un paio di tracce, inoltre, compaiono come ospiti i connazionali Steinar Krokstad e Per Hillestad, batteristi, rispettivamente, dei primi Stage Dolls e degli A-Ha.
Apre l’album “Gonna let you go” con un ritmo vivace, sul quale si staglia la voce estesa e pulita di Masaki a disegnare un brano di AOR moderno e costruito con gusto.
Più rarefatta l’atmosfera su “What can be done”, mid tempo in stile Journey ancora dominato dalle belle linee vocali e dalle soffuse tastiere di sottofondo.
Passiamo così a “Believing”, dove vengono prepotentemente a galla influenze Toto con tanto di stacchetto jazzato all’altezza del solo. Il risultato non è affatto disprezzabile, pur non presentando alcun tratto di originalità.
Il ritmo si rialza con “Calling all stations”, ma purtroppo solo quello della batteria: il pezzo è un po’ troppo arzigogolato nell’arrangiamento e scarsamente efficace emozionalmente.
Annovererei i Foreigner tra le influenze della band, almeno a giudicare dalla piacevole semiballad “Kaylee” sulla quale aleggiano piacevoli svolazzi blues della chitarra di Sennerud.
Toni relativamente più hard si possono sentire su “The devil never cries”, pezzo deboluccio a livello compositivo e poco convincente come linee melodiche.
Bella “Shivering hands”, una canzoncina che pare tratta da uno dei primi due dischi dei Nelson e che infonde un senso di positività nell’ascoltatore.
Purtroppo la title track rappresenta un altro netto calo della qualità compositiva del gruppo con coretto scialbo e poco incisivo e assunto strumentale mediocre.
Un bel brano di AOR moderno e ben suonato lo ascoltiamo, invece, con “Through the fire”: classico intreccio di chitarre e tastiere che ci conduce al ritornello, drammatico e catchy al punto giusto. Un pezzo che lascia sicuramente il segno.
Un improbabile mistura dei Toto di “Seventh one” e Nelson caratterizza “How does it feel”, non il massimo a livello di immediatezza ma apprezzabile come idea.
E si chiude con la lacrimuccia: “Fall” è un lentone strappalacrime, di quelli che tanto piacciono a chi scrive, dove la pregevole ugola di Masaki tocca vette espressive, oltre che tecniche, di notevole valore.
Vi dico francamente che, al primo ascolto, questo disco non mi è piaciuto un granchè. Contiene 2/3 canzoni veramente insufficienti ed in più è penalizzato da una produzione e da suoni tra i peggiori in cui mi sia capitato di imbattermi negli ultimi tempi. Mi sono intestardito a volerli riascoltare e rivalutare perché sono norvegesi. E dalla Norvegia arrivano bands tra le mie preferite in assoluto, come gli imprescindibili Stage Dolls (per me nell’olimpo dei 5 migliori gruppi al mondo) e gli altrettanto seminali Darkthrone… E, alla fine, parzialmente mi sono dovuto ricredere. Al netto della pessima qualità dei suoni, il disco scorre via piacevole, a patto di skippare sulle tre tracce meno azzeccate. La capacità interpretaiva di Masaki deve ancora farsi, però le sue doti sono innegabili. I musicisti sono in gamba… alla fine non è tanto peggio dei lavori che diversi grossi nomi hanno pubblicato nel 2020 e dai quali il sottoscritto è rimasto grandemente deluso.
Dai Stoneflower, appuntamento alla prossima release!
Robert Hart – Pure – Recensione
13 Gennaio 2021 3 Commenti Vittorio Mortara
genere: Aor
anno: 2020
etichetta: Escape
Lead vocalist in due album della Bad Company, chitarra e voce nell’indimenticabile “Under one sky” dei The Distance, leader dei Diesel di “Into the fire”, ottimo album AOR del 2014, membro dei Company Of Snakes, autore di una manciata di dischi solisti dal 1989 ad oggi. E ci sarebbe ancora molto altro da scrivere…
Inglesaccio fino al midollo, Robert Hart è ed è stato un personaggio di assoluto rilievo nel panorama Hard/AOR negli ultimi 30 anni: voce rock classica, graffiante ed adattabile a tutte le situazioni e alle varianti del genere, autore raffinato e chitarrista di buon livello. Oggi torna sulle scene come solista con questo “Pure”, un album stupendo!
Completano la lineup il grande Tommy Denander alle chitarre e tastiere, Michael Lange alla batteria e Bryan Anthony al basso. La produzione è affidata a Denander in collaborazione con Steve Overland degli FM.
Ragazzi, questo disco suona esattamente come dovrebbe suonare un album AOR negli anni 2000. Le canzoni sono tutte estremamente orecchiabili. Ci sono forti contaminazioni funky, pop e blues, ma non viene mai persa di vista la retta via del rock. La produzione ed i suoni sono di livello assolutamente superiore alla media. La classe dei personaggi coinvolti è evidente sin dal primo ascolto. In un attimo ti trovi all’ultima traccia senza il benché minimo calo di goduria!
Accidenti, ma è tanto difficile nel 2020 fare un disco come questo? Perché ce ne sono cosi pochi?!?!
Partiamo coi pezzi: “Makin magic” ci travolge subito col suo ritmo funky, chitarra e voce in bella evidenza ed un chorus che si lascia canticchiare facilmente.
Atmosfere westcoastiane su “Little miracle”, in cui la timbrica suadente di Robert domina un brando dal potenziale commerciale immenso.
Ancora funky su “Sensational” il cui refrain, accompagnato da pompose tastiere, si stampa inesorabilmente nel cervello.
“Go crazy” è una canzone dai fortissimi accenti pop, con una linea melodica blues/soul e l’inconfodibile voce di Steve Overland ai controcanti a mettere la ciliegina sulla torta.
Nella strofa della successiva “This is the night” fa capolino il miglior Michael Jackson. Assolutamente da urlo il ritornello ed il ficcante assolo di Denander.
Su “Different people” Hart riprende quelle sonorità a cavallo fra pop, soul ed AOR, tanto care a Michael Bolton e Richard Marx, confezionando un altro potenziale hit, stavolta nella forma di una meravigliosa semi ballad.
Poi, improvvisamente, si ricorda di essere stato il frontman della Bad Company, e ci butta lì un pezzo hard blues come “Double trouble” che ci fa andare su e giù la testa in preda al demone del rock!
“Chemistry” gronda classe da ogni nota, così perfettamente in equilibrio fra i Toto e gli FM, impreziosita ancora una volta dal frontman di questi ultimi ai cori.
Venature blues riaffiorano anche in “Mysterious”, stavolta in unitamente a quei fiati sintetizzati che fecero la fortuna di “Permanent vacation” degli Aerosmith. La voce di Overland si riconoscerebbe anche in mezzo a un coro di 100 elementi… altro pezzo piacevolissimo!
Ritmi jazzati per “Don’t make promises”, una splendida citazione dei Toto di Joseph Williams, con un Hart graffiante ed ispirato come non mai.
La dolce “Scene of the crime” avrebbe fatto sfracelli nell’airplay americano di 30 anni fa, così poppeggiante da somigliare a quanto di meglio espresso in passato da una band come i Simply Red.
“Colour of love” chiude degnamente questo splendido platter: pomp/AOR dotato di una linea melodica di facile presa, insomma un altro potenziale singolo da classifica (ovviamente, purtroppo, in un’altra epoca).
Bello questo disco. Proprio bello. Uno dei migliori che mi sia capitato di ascoltare quest’anno (2020 ndr). Mi rendo conto, di fronte a prodotti come questo, di quanto difficile mi risulti spiegare ad un potenziale fruitore il perché andarlo ad ascoltare. E’ semplicemente bello! Sono sempre più convinto che le vecchie leve abbiano classe da vendere. Quando hanno l’esperienza e le idee chiare come Hart, oltre ad un budget non troppo risicato per produzione ed arrangiamenti, non può che venirne fuori un album come questo “Pure”.
Consigliatissimo!
Crosson – Rock ‘N’ Roll Love Affair – Recensione
13 Gennaio 2021 2 Commenti Vittorio Mortara
genere: Glam
anno: 2020
etichetta: Galaxy Records
Jason Crosson è un buffone! Look fra il glam anni 80 più sguaiato ed i Tokyo Hotel, parruccone nero e fucsia, faccia da schiaffi non indifferente, testi tra l’ironico ed il demenziale, videoclip low cost coloratissimi e divertenti, una band di tamarri ad accompagnarlo insieme a due scosciatissime coriste. Un tipo così non si può e non si deve assolutamente prendere sul serio.
Dove invece il nostro non scherza, è sulla qualità del prodotto. Il rocker australiano si rifà soprattutto a band come Tigertailz, Shameless e Pretty Boy Floyd, con una spruzzata di 69 Eyes per via della tonalità della sua voce, dimostrandosi abilissimo a costruire canzoncine gradevoli, finalizzate essenzialmente a piazzare ritornelli estremamente catchy. E devo dire che il risultato è stato veramente centrato!
Se poi aggiungiamo che dietro a produzione e mixer ci sono due mostri sacri dell’epoca d’oro come Duane Baron e Dave Donnelly, non possiamo che prendere nota della cura che Jason ha riservato a questo disco.
Praticamente sconosciuti al di fuori di Australia e Germania (!), sugli esordi della band galleggiavano scorie di dark ed elettronica che sono state poi epurate nei due album del 2016 e 2018, per arrivare al sound “perfetto” di questo “Rock’n’roll love affair”.
Pronti, via ed è subito “Everyone’s a star” con il suo riff facile facile ed un bel coro da canticchiare.
Poi tocca a “Givin’up livin’ givin’up”, caratterizzata da un altro semplice ma efficace giro di chitarra e da hooklines azzeccatissime!
“Rest in peace” è dedicata alla morte della mamma come solo Jason Crosson può fare: con serenità e senza un minimo di melodrammacità. D’effetto l’apporto delle coriste.
Leggera virata in territori class metal per “We all need an enemy”, con il suo ritmo incalzante e la solista che se la cava alla grande.
“Week on my knees (for a hot brunette)” è la mia preferita, tra Quireboys e Pretty Boy Floyd, con un coro che canteresti a squarciagola! E il video? Stupendo, secondo solo a “Heart of stone” di Gianluca Firmo, quello vero, quanto a comicità demenziale!!!!
La kissiana title track è forse il pezzo che mi piace meno, mentre “Possessed” riporta le coriste sugli scudi, dopo una strofa che ricorda non poco i Type’0’Negative per il vocione profondo alla Peter Steele.
Introdotta dal piano, come tradizione dei lenti glam, “You’re the reason” è una ballad dal messaggio positivo che piace per il suo essere così fuori moda.
E veniamo a “Merry go round”. La canzone è un plagio. Se poco poco conosco Crosson, penso, però, che sia una provocazione voluta. Una sorta di strano tributo a Bon Jovi a modo suo. Un bizzarro modo di fare una cover, insomma. Non sono d’accordo con chi ha gridato allo scandalo, dai. Lo abbiamo detto all’inizio: Jason Crosson è un buffone bisogna entrare nell’ottica del suo umorismo dissacrante. Ma l’avete mai sentita “I wanna be japanese” dal suo album del 2016? Detto questo, non vi suggerisco quale sia la canzone plagiata/coverizzata perché la indovinerete già alla prima strofa…
E siamo già alla fine del disco: l’up tempo “Back on the attack” ne è la degna chiusura, ancora una volta un brano orecchiabile ed energetico.
Allora, tiriamo le somme. Su “Rock’n’roll love affair” non troverete la minima traccia di originalità. Non troverete musicisti funambolici né una voce dal timbro stentoreo che vi faccia accapponare la pelle ad ogni acuto. Sicuramente non è un album che riascolterete mille e mille volte nei prossimi 20 anni. Ma se volete concedervi una pausa allegra, se volete qualcosa di leggero da mettere su per passare un’oretta a sentire qualche canzone ben confezionata e magari a cantare qualche bel refrain, allora è senz’altro l’ideale!
Bravo Crosson!
Perticone – Underdog – Recensione
13 Gennaio 2021 0 Commenti Paolo Paganini
genere: AOR/SOUTHERN ROCK/COUNTRY
anno: 2020
etichetta: Aor Heaven
Immagino che molti di voi come me non conoscessero il nome di Martin Perticone fino ad oggi. In realtà il musicista, produttore, manager di Buenos Aires è nel giro da parecchio tempo pur non avendo mai pubblicato un vero e proprio album a proprio nome. L’esperienza accumulata e l’amicizia con musicisti di spicco (Eric Martin e Steve Overland sopra tutti) lo hanno indotto a mettere su cd 9 tracce di genuino AOR influenzato qua e la da Southern Rock alla ZZ Top come nel caso della carichissima “Out Of Control” o dal Country di “All You Can Trust” dove alla voce troviamo proprio il singer dei Mr. Big. Overland viene invece arruolato per aprire le danze on la Defleppardiana “No One Else” che ci riporta in pieni anni “80 territorio su cui il nostro si muove con maggiore disinvoltura. “Man On The Moon” è un altro ottimo esempi di AOR di grande impatto e facilmente assimilabile fin dal primo passaggio. Con “Giselle” e “Dusty Road” si torna al Pop Country in stile Kid Rock con la prima nettamente più convincente della seconda. “Back To My Heart” ci dimostra cosa Martin sa fare meglio; una sognante power ballad a metà tra il Modern Rock alla Creye e le sonorità dei Toto di The Seventh One. La title track è pop rock all’ennesima potenza sulle stile dei The Rembrants (ricordate la famosa sigla della serie tv Friends?). In chiusura viene riproposta una nuova versione di “All You Can Trust” in cui Martin duetta con Eric Martin.
IN CONCLUSIONE:
Uniche pecche di questo debutto una produzione un po’ artigianale e i suoni troppo plafonati che da una parte penalizzano il voto finale ma dall’altra ci fa apprezzare la passione e l’impegno profuso dal buon Martin Perticone che se adeguatamente supportato potrebbe riservarci delle piacevolissime sorprese nel prossimo futuro.
Vodoo Circle – Locked & Loaded – Recensione Breve
10 Gennaio 2021 1 Commento Samuele Mannini
genere: Hard rock
anno: 2021
etichetta: AFM Records
Mi sono accostato a questo disco per la curiosità delle atmosfere Whitesnake evocate dai lavori precedenti di Alex Beyrodt e per la presenza di David Readman , che avevo apprezzato nei lavori dei Pink Cream 69 e Room Experience. Devo dire che sono rimasto a dir poco deluso, non voglio essere frainteso , due o tre canzoni sono belle e di spessore , ma qui non si respira l’atmosfera Whitesnake , sembra più una ossessione. Tutto il disco ruota infatti a riff e armonie prese a piene mani da 1987, Slip of the Tongue e dal primo Blue Murder, con qualche variazione marcatamente Zeppelin e Badlands. Ecco è tutto qui , anzi, è solo così, dall’ inizio alla fine ed anche per me che sono un adoratore del Serpente Bianco è francamente troppo. Nelle uniche canzoni meno referenziali noto una certa confusione come, nella a tratti rappeggiante, Locked & Loaded che poggia su un inconcludente giro tastieristico pseudo Zeppelin.
Insomma a qualcuno sicuramente piacerà , dopotutto le performance degli esecutori sono degne e tecnicamente ineccepibili . Qualche canzone, per esempio Magic Woman Chile, pur sfacciatamente Kashmir style è carina, Devil’s Cross e This Song Is For You sono gradevoli e ben congegnate, ma per il resto è più una caccia alla somiglianza con i gruppi sopracitati che un ascolto godibile.
Lascio dunque volentieri decidere a chi lo ascolterà se io abbia preso o meno una cantonata, anzi, per i fan del genere Trivial Pursuit , potrebbe essere un passatempo carino cercare di ricordare le canzoni che hanno fatto da spunto per il disco, però da artisti di questa caratura mi sarei aspettato di più.
Albert Bouchard – Re Imaginos – Recensione
27 Dicembre 2020 4 Commenti Davide Arecco
genere: Hard 'N' Heavy
anno: 2020
etichetta: Deko Entertainment
Mentre i Blue Oyster Cult sono ritornati, alla grande, con The Symbol Remains e sempre la Frontiers ha dato alle stampe diversi loro pregevolissimi live, l’ex-batterista Albert Bouchard si fa anche lui sentire, tornando a raccontare tales from outer space di intelligenza extraterrestre ed invasori alieni.
Questo suo Re Imaginos, come anticipano il titolo ed una grafica a dir poco stupenda, è un rifacimento ed insieme un completamento della saga fantascientifica di Imaginos, lo storico e splendido disco che nel lontano 1988 i BOC pubblicarono con grande apprezzamento di critica e fans. I pezzi, in questa nuova versione – che punta maggiormente su arrangiamenti elettro-acustici, sia pure senza essere un unplugged –, sono saliti da nove a dodici (come simboli astrologici e costellazioni dello Zodiaco, temi da sempre cari alla cerchia del Culto dell’ostrica blu). I brani sono stati redistribuiti equamente, in quattro parti: Quandary, Subline, Ghost e Dance. L’album è stato realizzato con quei musicisti e roadies che già contribuirono, nel lontano 1988, alla registrazione di Imaginos: Jack Rigg alla chitarra, Kenny Aaronson al basso, Jack Secret ai cori, Tommy Zvoncheck e Tommy Mandel alle tastiere, Thommy Price alla batteria ed infine Tommy Morrongiello alle chitarre. La musica resta bellissima e dal gusto classicamente melodico. Sul piano lirico e contenutistico, inoltre, possiamo (forse) dire che Re Imaginos rimette in ordine i diversi e criptici capitoli di quella storia di sf esoterica che i Blue Oyster Cult hanno disseminato nei loro dischi, sin dagli esordi. Una storia che lo stesso Imaginos non aveva ancora illustrato in tutta la sua esauriente completezza, lasciando cose da spiegare e molti dubbi agli appassionati, circa determinati significati ed aspetti della trama sottesa alla musica e raccontata nei testi. Una storia che occorre ripercorre, risalendo alle sue lontane e remote origini, quando il gruppo non si chiamava ancora Blue Oyster Cult.
continua
L.A. Guns – Renegades – recensione
24 Dicembre 2020 7 Commenti Stefano Gottardi
genere: Hard Rock/Rock'n'Roll
anno: 2020
etichetta: Golden Robot Records
Gli L.A. Guns si formano a Los Angelese nel 1983 e, oltre al chitarrista Tracii Guns, nella band c’è un ancora sconosciuto Axl Rose, che in breve tempo molla per fondare gli Hollywood Rose. Dalla fusione dei due gruppi nascono i Guns N’ Roses, che a sua volta Tracii lascia venendo rimpiazzato da Slash. A quel punto riforma gli L.A. Guns con nuovi musicisti, fra cui il cantante Paul Black. Dopo qualche demo nel 1987 dietro al microfono prende posto il britannico Phil Lewis dei Girl; nel 1988 invece il batterista ex W.A.S.P. Steve Riley si accomoda ai tamburi. Sono ben quattro i dischi che bene o male manterranno la stessa formazione (Phil Lewis, voce; Tracii Guns e Mick Cripps, chitarre; Kelly Nickels, basso e Steve Riley, batteria), prima che American Hardcore del 1996 stravolga tutte le carte in tavola, sia a livello stilistico che di line-up, tenendo dentro solo Guns e Riley. In mezzo, nel 1994, c’è un altro temporaneo scioglimento. Licenziato il nuovo cantante Chris Van Dahl (già noto come Roxy Dahl nei Cherry St.), ingaggiano Raplh Saenz (oggi conosciuto come Michael Starr negli Steel Panther) e danno alle stampe un EP. Nel 1998, perso per strada Saenz, prima assumono per un breve periodo Joe Leste dei Bang Tango, poi prendono Jizzy Pearl dei Love/Hate e con lui un anno dopo pubblicano un nuovo full-length, Shrinking Violet. Nel 2001 tornano con l’album Man In The Moon e nel 2002 con Waking The Dead, e con Lewis, Guns e Riley ancora a bordo. Nel 2003 Tracii abbandona a favore dei Brides Of Destruction, mentre la band afferma di averlo licenziato creando la famosa spaccatura fra Guns e Lewis che si ricompatterà solo diversi anni dopo. Con Stacey Blades (Roxx Gang) alla sei corde, fra il 2004 e il 2005 arrivano Rips The Covers Off e Tales From The Strip. Nel frattempo Tracii si riunisce al vecchio cantante Paul Black e realizza l’album Black List come Paul Black’s L.A. Guns. Fino al 2012, anno in cui il chitarrista scioglie la sua versione, esistono due gruppi con lo stesso nome, uno capeggiato da Tracii, l’altro da Phil. Quest’ultimo nel 2012 dà alle stampe Hollywood Forever. Nel 2016 i due si ritrovano e il singer lascia di fatto la band con Steve Riley, pubblicando due lavori col suo vecchio compagno di scorribande, The Missing Peace (2017) e The Devil You Know (2019). Nel Gennaio del 2020 il duo denuncia Riley per aver continuato ad utilizzare lo storico monicker, con cui in tempi più recenti ha messo sul mercato Renegades. Questa è a grandi linee la storia degli L.A. Guns, riassunta in forma sintetica per cercare di fare un po’ di chiarezza su un gruppo che nel corso degli anni non ha fatto nulla per non rendere complicata la sua avventura. Talmente complicata che, se ci chiedessero di puntare un euro sulla precisione della ricostruzione che avete appena letto, probabilmente non lo faremmo, ma in qualche maniera dovrebbe avere contribuito a spiegare un po’ meglio gli eventi che hanno portato alla situazione attuale che vede ancora una volta due diverse versioni della band contendersi lo stesso nome.
Pendragon – Love Over Fear – Recensione
23 Dicembre 2020 28 Commenti Samuele Mannini
genere: Progressive Rock
anno: 2020
etichetta: Toff Records
Fine anno è periodo di classifiche e di considerazioni sull’anno che è appena trascorso e se per via della Pandemia è stato un anno orribile , musicalmente è invece stato un anno ricco un po’ in tutti i generi. Questo è per me il disco più bello uscito in questa delicata annata, sono perfettamente conscio che sia leggermente off topic rispetto a ciò che abitualmente viene trattato su questo sito, ed anche che oramai il disco sia uscito un po’ di mesi fa, quindi perché parlarne? Intanto quando uscì Love Over Fear io non collaboravo ancora con Melodicrock quindi era impossibile, secondo, ritengo che il prog. ( o almeno il neo prog.) abbia numerosi punti di contatto con l’Aor e il Melodic rock in generale, tanto che, numerose volte in passato, abbiamo assistito a tentativi più o meno riusciti di commistione ed influenze tra i due generi. Ho quindi chiesto una deroga al ns. Boss Denis Abello, che ha gentilmente acconsentito a lasciarmi scrivere queste righe, vedremo se sarà cosa gradita o no.
Veniamo dunque al disco in se , un evento che va degnamente celebrato ed adeguatamente spiegato perché oltre ad essere un capolavoro è il dodicesimo album in studio che copre una carriera discografica di ben 36 anni.
Ora parliamo chiaro, i Pendragon dischi mediocri non ne hanno mai fatti ed anche Passion, che è quello che mi piace meno, è un disco degno, ma qui secondo me si apre un nuovo ciclo artistico dalle estatiche premesse.
Come mi confermò anche Nick Barrett quando ebbi modo di parlarci una mezz’ora vis a vis in occasione del tour di Pure, dopo che il primo ciclo artistico si era chiuso con Not of This World e un’altro ne era cominciato con Believe ( basta anche guardare le copertine dei dischi per capirlo) i Pendragon avevano deciso di esplorare sonorità più ‘dure’ e moderne uscendo un po’ dai cliché classici del neo prog , il percorso si è concluso con Men Who Climb The Mountain, e qui si torna un po’ indietro nel tempo quindi, andando a riscoprire il gusto tipico delle atmosfere degli album più classici quali The world and Masquerade Overture.
Musicalmente Love Over Fear è dunque una sintesi ideale tra i due cicli dove l’introspezione più oscura degli ultimi album, viene mitigata dalle atmosfere sognanti del primo ciclo, mantenendo però una certa modernità sonora. Che meraviglia!
Dieci canzoni che sono un vero e proprio viaggio evocativo e sognante, nella speranza e nella vita, che ci pone sempre di fronte nuovi interrogativi da esplorare intimamente per andare avanti.
Non ho la minima intenzione di affrontare le canzoni una per una perché il lavoro mi è parso talmente organico che non ascoltarlo nella sua interezza, sarebbe come leggere un libro a cui sono state strappate pagine a caso, citerò quindi solo qualche esempio: Starfish And The Moon, una canzone onirica con chitarra ed una partitura d’archi da brividi. Truth and Lies song intensa, impreziosita da splendidi suoni e da uno struggente assolo di Barrett. Citerò infine Water , che si apre con un arpeggio acustico, crescendo su una trama tastieristica , fino ad esplicitarsi in una magia di melodie ed atmosfere.
Insomma nella loro quasi quarantennale carriera i Pendragon piazzano l’ennesimo colpo da maestro che magari potrebbe invogliare a conoscerli anche da parte di chi ha sempre giudicato il prog. un genere col naso arricciato all’insù. Con un minimo di mente aperta le atmosfere di questo disco vi dischiuderanno davanti agli occhi mondi fantastici che avete finora solo sognato.
Palace – Rock And Roll Radio – Recensione
17 Dicembre 2020 11 Commenti Giulio Burato
genere: Melodic Rock
anno: 2020
etichetta: Frontiers
Terza uscita discografica per il polistrumentista Michael Palace che segue il buon esordio “Master of the Universe” del 2016 e il secondo “Binary Music” del 2018. Nel bel mezzo dei due, ho il ricordo di una prova live, tutt’altro che positiva, al Frontiers festival del 2017.
In questi quattro anni di acqua sotto i ponti ne è passata; la folta chioma degli esordi è sparita, sono man mano diminuiti, in fase di registrazione, i componenti della Palace band, ma soprattutto il ragazzo svedese ha aggiustato il tiro a livello vocale; infine, la sua proposta musicale è più omogenea, un AOR che comunque spazia da Europa a resto del mondo.
Si inizia con la spumeggiante title-track che ci riporta alle colonne sonore dei film anni’80, ricca di tastiere e con un refrain ispirato che si stampa immediatamente in testa. Seguono altre tre perle, una dietro all’altra. La freschezza di “Castaway”, il primo singolo “Way up here” che alza l’asticella a livelli noti solo al mitico Sergej Bubka, e il recente singolo “Cold Ones” che fa l’occhiolino ai grandi maestri del genere, Toto su tutti.
A metà scaletta troviamo la ballad “Eleonora” che mi trasporta al primo, bellissimo, lento “Rules of the game”, presente nell’album di esordio. La voce è però maggiormente controllata e il ritornello vola via leggiadro.
Con un titolo così, la successiva “Hot steel” non poteva essere che graffiante e la più ritmata del lotto.
“My gray cloud” è sinuosa come le rampe della cima Coppi al giro d’Italia; con questo brano Michael ci dimostra grande perizia tecnica con variazioni interessanti. “Origin of love” è una tappa pianeggiante, o meglio, evitando argomenti ciclistici, è una canzone più basica che non sposta il livello, alto, sinora ascoltato.
Dopo un passaggio tranquillo, la nona traccia “She’s so original” porta in dote uno dei ritornelli che mi hanno maggiormente conquistato. Un pop-rock davvero sublime che mi catapulta a grandi momenti sonori degli anni’80. Sulle stesse coordinate pop-oriented “Strictly by the rules”.
Chiudono la release, la raffinata classe di “When it’s over” con un gioco di tastiere che piace e la briosa “Fight” che lascia il segno per struttura e ritornello.
Conclusioni:
In questo finale di 2020, anno da dimenticare, “Rock and roll radio” è un’iniezione di solarità e freschezza. Ogni tanto, la musica ci dà soddisfazione e Michael Palace dà il suo contributo con un album che lascia sicuramente il segno.
Bill Leverty – Divided We Fall – recensione
17 Dicembre 2020 2 Commenti Stefano Gottardi
genere: Hard Rock
anno: 2020
etichetta: Autoproduzione
Nuovo album per il chitarrista dei Firehouse Bill Leverty, la cui carriera solista prende vita nel 2004, un anno dopo quella che ad oggi è ancora l’ultima vera e propria fatica in studio della band madre. A prima vista il packaging del CD è deludente: il supporto è sì silver pressed, ma il jewel case ha il tray nero e contiene un booklet di sole due pagine, con la copertina da un lato e i credits dall’altro. Sotto questo aspetto il lavoro di un’etichetta sarebbe sicuramente servito a migliorare le cose. Messo il dischetto nel lettore, però, la partenza riservata da “You’re A Natural” è talmente buona da fare quasi dimenticare questo particolare. Il brano scopre subito le carte, visto che l’album poi non si allontana mai molto da queste coordinate sonore. L’hard rock blueseggiante tinto di atmosfere southern e funk di Leverty privilegia sempre la penna piuttosto che la sei corde, offrendo un songwriting di pregevole fattura, maturo e sfacciatamente melodico, ma senza mai affondare il colpo verso lidi commerciali. Dopo la sopraccitata opener, l’hard bluesy di “Strong” e quello più squisitamente 80s di “The Bloom Is Off The Rose” tengono alta l’asticella, che tuttavia si abbassa un po’ con lo scorrere della tracklist. In generale, comunque, il disco non perde mai quota e fa registrare almeno un altro paio di impennate con la catchy “Love Is Like A Song” e con la country-oriented “For Better Or Forget It”. Con il batterista dei Firehouse Michael Foster su sette canzoni, Andre LaBelle (Vinnie Vincent Invasion/Josh Todd) sulle restanti tre, e l’ottimo Keith Horne (Peter Frampton/Heart) al basso, la sezione ritmica è di qualità. Forse sottovalutato come chitarrista, Leverty non è invece un cantante memorabile, ma un po’ come quello studente che pur non essendo particolarmente dotato si arrangia, in qualche modo porta sempre a casa il sei. E buono è anche il suo lavoro in cabina di regia. Evitando di autocitarsi (i riferimenti ai Firehouse, se ci sono, sono poco marcati e mai in direzione di quel sound che ha fatto la fortuna del gruppo all’inizio degli anni Novanta), l’axeman americano non perde mai la bussola conducendoci sapientemente al decimo brano senza annoiare.
IN CONCLUSIONE
Leverty si è preso sei anni per confezionare e dare alle stampe questo disco, pubblicando di tanto in tanto qualche pezzo in streaming. Nonostante questa lunga gestazione, Divided We Fall non è un capolavoro. Dall’altro canto, però, si tratta di un prodotto gradevole, il cui ascolto riesce comunque a garantire poco più di 40 minuti di spensierata armonia, specialmente per chi apprezza artisti come Whitesnake, Gary Moore e ZZ Top.










