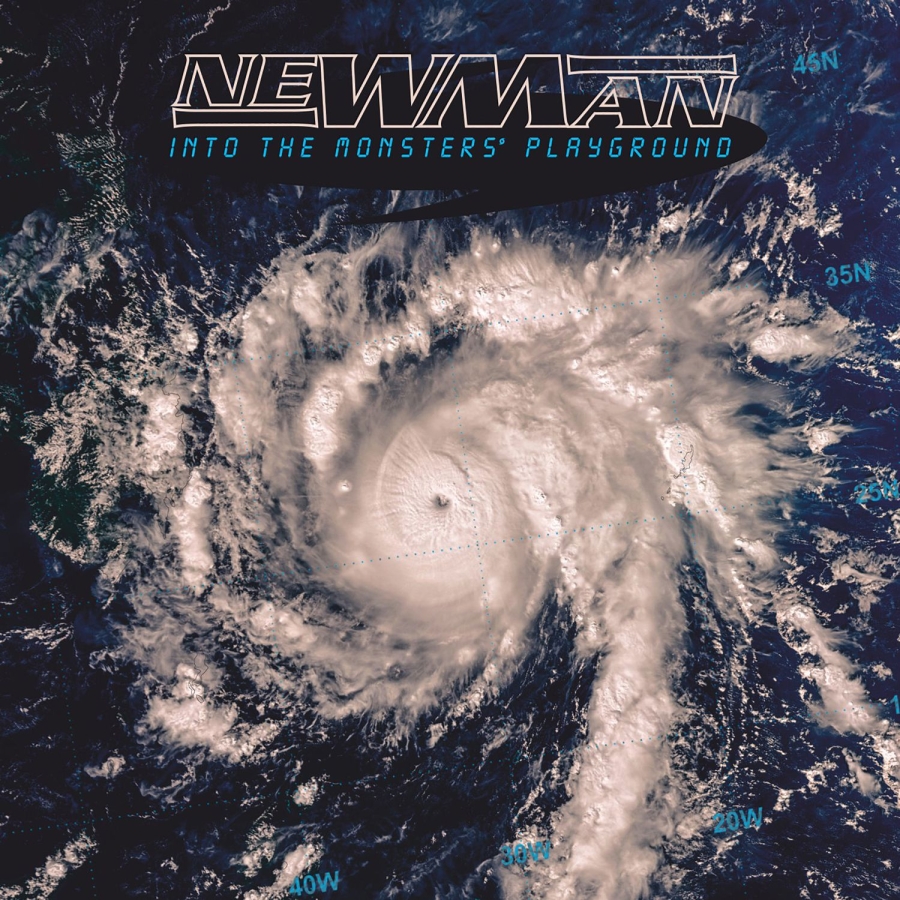LOGIN UTENTE
Registrati a MelodicRock.it

Registrati gratuitamente a Melodicrock.it! Potrai commentare le news e le recensioni, metterti in contatto con gli altri utenti del sito e sfruttare tutte le potenzialità della tua area personale.
effettua il Login con il tuo utente e password oppure registrati al sito di Melodic Rock Italia!
Ultime Recensioni
- Home
- /
- Ultime Recensioni
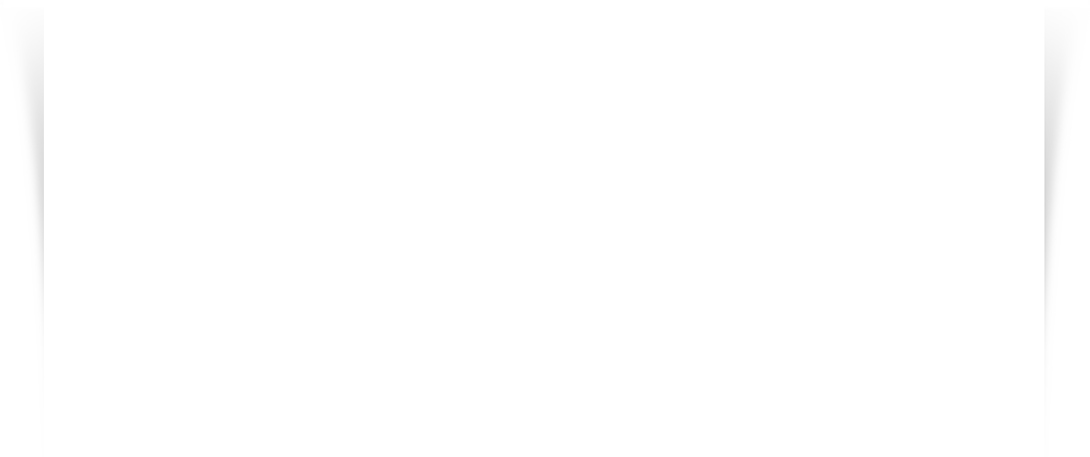
Jac Dalton – Tempus Fugit – Recensione
16 Novembre 2021 0 Commenti Vittorio Mortara
genere: Hard Rock
anno: 2021
etichetta: Skyfire Promotions
Jac Dalton ci viene presentato come un gentleman ribelle del sud. Alle sue spalle ben 4 album che, a quanto pare, hanno raccolto un discreto successo in patria (l’Australia) ma che, per quel che ne so io, qui da noi non hanno praticamente mai fatto capolino. La sua voce, che ricorda vagamente quella del supereroe danese Michael Kratz, non impressiona per estensione ma riesce discretamente nelle interpretazioni. Intorno al frontman suonano ben 6 elementi che, pur non conoscendoli affatto, mi paiono dei discreti musicisti; in particolare il guitar hero Graham Greene, autore di pregevoli riff e assoli lungo tutti i 15 pezzi che compongono questa raccolta. Perché di una compilation si tratta, nella quale Dalton ed il management della Skyfire hanno cercato di condensare il meglio della carriera del cantante. I brani vertono, con poche digressioni, su un hard/southern rock dalle tinte molto allegre e sbarazzine e, soprattutto grazie alle partiture corali e agli inserti di sax ed altri strumenti “non convenzionali”, fa qualche puntatina nell’honky tonk e nel country. Una specie di Jimmy Barnes meno melodrammatico. Menzione d’onore per le AORggianti “For your love” e “Just enough to believe”, per le ritmate hard country “Dirty, mean & nasty” e “Good bad girl”, per il lento gospel “One heart, one land” e per quello vendittiano (!!!) “Fire burns”, ed infine il blues rovente della conclusiva “When I’m alone with you”. Da dimenticare le cover di “Sweet emotion” e “Wanted, dead or alive”.
Riassumendo, direi che, pur non essendo un brutto album e pur con la menzione d’onore alla Skyfire per il promo in formato WAV, mi sentirei di consigliare l’acquisto solo a chi apprezza (anche) questo genere oppure si nutre di qualsiasi uscita decente nell’hard e dintorni, nel senso più ampio del termine.
Wayward Sons – Even Up The Score – Recensione
16 Novembre 2021 0 Commenti Alberto Rozza
genere: Hard Rock
anno: 2021
etichetta: Frontiers
Grande ritorno per i britannici Wayward Sons, con un nuovo album di studio: chissà cosa bolle in pentola e se sapranno stupirci!
“Even Up The Score”, prima traccia e title track, dà il via a questo lavoro: un brano corale, sostenuto e puramente hard rock, che contiene tutti i punti riconoscibili e canonici della band. Arriviamo a “Big Day”, dalla linea scanzonata, coinvolgente e classica, complessivamente un pezzo gioviale e ben strutturato. “Sign Of The Time” ha una bella pacca ritmica e un gusto particolarmente vintage, dimostrandosi molto convincente anche nel delizioso assolo incrociato. Ci si rilassa un attimo con “Bloody Typical”, quadrata e cesellata nei minimi particolari, un brano che lascia sensazioni molto positive nella mente dell’ascoltatore. Sempre su quest’onda molto rilassata e rilassante troviamo “Faith In Fools”, molto emozionale e intenso, che si riversa
nella successiva “Fake”, strumentalmente molto interessante. Toni più brutali accompagnano “Downfall”, piacevole e leggermente diversa rispetto al panorama timbrico di questo album. “Tip Of My Tongue” non si discosta molto dalle altre tracce, portandoci in un’atmosfera più cupa e sofferente. Cambiamo totalmente percezioni con “Looking For A Reason”, decisamente solare e ariosa, puramente hard rock, evocativa e divertente. Arriviamo a “Land Of Blind”, che resta impresso nella memoria: il ritornello è particolarmente orecchiabile così come il groove complessivo del brano. Passata senza troppi rimpianti “They Know”, abbastanza anonima, arriviamo alla conclusione di questo lavoro con “The Party’s Over”, finale naturale di questo album, che ci lascia con una band sempre in crescita, anche rispetto all’ultimo disco, ma che sempre, si voglia per il genere o per altro, pecca un po’ in originalità.
Black Diamonds – No Tell Hotel – Recensione
15 Novembre 2021 1 Commento Vittorio Mortara
genere: Street/Glam
anno: 2021
etichetta: Metalpolis
Posso ben sostenere di essere stato fortunato perché negli anni immediatamente precedenti a questa accidenti di pandemia sono riuscito ad andarmene su e giù per l’Europa a godermi qualche bel festival della nostra amata musica: HEAT, AOR Convention, Frontiers, Frontiers Scandinavia. Ed in quelle magnifiche giornate ho avuto l’onore e il piacere di ascoltare dal vivo decine di gruppi, più o meno famosi. Tra questi ultimi ho incrociato anche questi elvetici Black Diamonds dell’eccentrico singer Mich. I nostri dal vivo se la cavano bene. Hanno alle spalle una manciata di lavori, tutti ben realizzati. Il genere proposto è uno street/glam più canonico e meno modernizzato rispetto a quello, per esempio, dei Crash Diet. In più la presenza fisica dei ragazzi è assai meno piaciona rispetto ai cugini biondi, nonostante l’acconciatura improponibile del cantante. Al contrario la tecnica individuale è assolutamente all’altezza del genere e la produzione, pur non facendo gridare al miracolo, è ben al di sopra di tanta roba ascoltata ultimamente. Insomma, questi ragazzi hanno le carte in regola per ritagliarsi un angolino nell’ormai ristretto settore del rock’n’roll sguaiato, cotonato e paiettato di Sunset Boulevardiana memoria. E ci provano ancora con questo nuovo “No tell hotel”, senz’altro non un capolavoro assoluto né una pietra miliare nel genere ma costituito sulle ottime basi di cui vi ho parlato pocanzi. E infatti le canzoni si alternano facendoti battere il piedino ed alzare il pugno chiuso al cielo, come si confà ad un album glam.
Si comincia con il riffaccio sporco della title track, decisamente non il miglior pezzo dell’album, un tantino arzigogolata. Ma “Evil twin” aggiusta il tiro con un brano di moderno rock stradaiolo dal refrain killer. L’incipit acustico di “Lonesome road” fa strada a una canzone che profuma di deserto dell’arizona e Mustang cabriolet. Ancora street metal a manetta per “Forever wild”, mentre “Saturday” fa l’occhiolino al glam caciarone dei Pretty Boy Floyd. “Anytime” è il primo lento del disco. Bello il piano di sottofondo e degna di menzione l’interpretazione sentita di Mich, molto ma molto vicina al mitico Joe Elliott. Carino anche il boogie di “The Island” e l’hair metal di “My fate”. Ed è la volta del secondo slow, “Hand in hand”, stavolta Bon Jovi style, assolutamente convincente sotto tutti i punti di vista. “Reaching for the stars” invece non lascia particolarmente soddisfatti, al contrario di “Turn to dust” che ti trascina a colpi di whoa whoa e di riff taglienti. E poi mi trovo misteriosamente catapultato nel cuore del far west con l’allegra “Outlaw”, tre minuti e mezzo di puro divertimento a chiusura del disco.
Direi che il loro compito i ragazzi l’hanno svolto piuttosto bene. Un disco glam deve procurare sano e spensierato divertimento, e questo “No tell hotel” ci riesce perfettamente. Un album che consiglio senza timore a tutti i fans di Crash Diet e Crazy Lyxx, nonché Tigertailz, Pretty Boy Floyd e certi Poison. Ma anche a tutti gli altri dico che un ascolto lo vale di certo.
Six Silver Suns – As Archons Fall – Recensione
14 Novembre 2021 2 Commenti Samuele Mannini
genere: Hard Rock
anno: 2021
etichetta: Aor Heaven
A Cura di Samuele Mannini e Max Giorgi
Aor Heaven mette a segno un altro colpo a sorpresa in questo 2021 all’insegna dell’abbondanza di uscite e anche abbastanza prodigo di qualità. Nel panorama Rock ed affini scandinavo i gruppi Finlandesi di solito sono quelli che meno hanno paura di sperimentare un po’ e questi Six Silver Suns ne danno ampiamente prova, non che inventino nulla o che rivoluzionino i suoni in maniera eclatante, ma riescono a miscelare stili diversi e arrangiamenti vari in tutte le canzoni di questo loro debutto, rendendo l’ascolto piacevole e stuzzicando la curiosità canzone dopo canzone.
Album di esordio dunque, ma i protagonisti non sono certo degli sbarbati capitati qui per caso, ma provengono tutti da trascorsi in gruppi storici dalla scena rock Finnica. Il genere proposto è difficilmente classificabile a priori, perchè mescola sonorità melodic rock ad atmosfere seventies e come dicevamo arrangiamenti originali, oltre a sciorinare cori ed intrecci vocali ,con voce femminile, di grande impatto. Se proprio vogliamo trovare dei punti di contatto una band che li ricorda sono i Cats In Space, anche se qui viene privilegiato il lato più progressivo delle sonorità Blue Oyster Cult, invece delle atmosfere un po’ pomp alla Styx/Boston predilette dai Cats.
Per il resto bisogna approcciare questo disco con libertà mentale e senza preconcetti ed allora le soddisfazioni arriveranno gradite e quasi insperate.
Lord Of The Southern Tower apre il disco con il suo incedere vagamente ‘reggaeggiante’ , si sviluppa poi in una armoniosa spazialità con tinte seventies, mentre la seguente To The Unknown deve il suo mood al rock melodico di matrice più tipicamente scandinava, vi ricordate gli Street Legal? In questo brano dall’ incedere maestoso me li ricordano abbastanza. Children Of The Stars e Fading by Light associano ritmo e melodia catchy con suoni che, qua e la, ricordano il tanto amato vecchio prog. Sarà questo il filo conduttore che legherà tutti i brani, un giusto connubio tra melodia ed ambienti forse un po’ retrò ma con suoni comunque moderni. L’ombra dei Blue Oyster Cult ogni tanto fa capolino, ma in modo discreto e mai troppo insistente come in Sweet Promethean. Ed un po’ di sano rock/blues? Tanto per saltare un po’? Ecco che i nostri Six Silver Suns ci regalano la ritmata Cosmic Bitter Blues con chitarra e pianoforte sugli scudi. Mentre The stranger passa in maniera abbastanza anonima, merita una menzione particolare la successiva Volture of Nevermore, uno dei brani piu riusciti di questo album con continui cambi di atmosfera, suoni, ritmi e l’ottima amalgama tra voce maschile e femminile. Ottima dimostrazione delle capacità sia di composizione che di esecuzione di questa band. Il groove e la melodia non ci abbandonano nemmeno nelle successive Edge Of Forever e nella sognante e romantica A Night Upon My Shoulders che è forse il brano più radiofonico ed AOR di questo As Archon Fall (bellissimo ed evocativo anche il titolo). Album che termina con una chicca, la cover di California Dreamin dei celeberrimi The Mamas And The Papas, qui proposta più rock con sonorità alla The Reaper.
Alla fine dell’anno arriva questa sorpresa gradita , quindi orecchie aperte e mano al portafogli.
David Reece – Blacklist Utopia – Recensione
12 Novembre 2021 0 Commenti Giorgio Barbieri
genere: Hard Rock
anno: 2021
etichetta: El Puerto Records
David Reece è un highlander, un rocker vero, che ha sempre toccato il successo senza goderne mai appieno, prima i con Bangalore Choir, poi con gli Accept, quindi con i Bonfire, giusto per citare le band più famose, oltre a molte altre , finchè non ha deciso di giocarsi le sue carte in maniera totalmente libera, da prima con il progetto Reece, poi con quest’altro che porta il suo nome completo.
Non ho mai approfondito la carriera del cantante di Oklahoma City e posso dire di conoscerlo solo per lo stupendo debutto dei Bangalore Choir e per lo sfortunato “Eat the heat”, ottavo album degli Accept, ricordo comunque due interpretazioni magistrali con la sua voce grintosa, a volte coverdaliana e in questo album, come già nel precedente “Cacophony of souls”, uscito l’anno scorso, il buon David si cimenta in quell’ hard rock ai confini del metal, con il quale è cresciuto e a dire il vero, riesce a smuovere la mia malandata capoccia, non sempre, ma ce la fa. L’album non è niente di eccezionale e di questi tempi una proposta del genere può risultare anacronistica, ma la passione che ci mette David, unito allo stupendo lavoro di chitarra di Andy Susemihl, ex UDO e Sinner, alza il voto che da un’anonima sufficienza ad un più che buon sette.
L’album si apre con “Utopia” un metal old style con delle atmosfere addirittura da nwobhm e prosegue tra alti, la bella ballad semiacustica “American Dream”, dove i riferimenti a Coverdale sono abbastanza chiari, l’hard’n’heavy dal bel ritornello di “Devil at my doorstep”, la conclusiva vigorosa “Book of lies”, pezzo veloce che si apre in un coro arioso, e bassi, quali “Civil war”, pezzo formalmente bello, ma con un ritornello un pò forzato, così come “Most of the time” e la anonima “I can’t breathe”( il cui testo fa però riferimento al caso dell’ omicidio di George Floyd), ma gli altri brani, tra i quali segnalo l’anthem “Red blooded hellraiser” che sa tanto di Saxon e il semplice, ma efficace “Before we fade away” fanno sì che “Blacklist utopia” venga ricordato come l’ennesimo buon episodio tagato David Reece. Ripeto, niente di fondamentale e soprattutto, dato il target medio di chi legge queste pagine, forse anche troppo vigoroso, ma chi mi conosce, sa che io apprezzo il lato più metallico del buon vecchio hard rock, per cui auguro lunga vita al rocker statunitense finchè ci allieterà con la sua musica, che lascia poco all’imprevedibiltà, ma che brucia di vita sulla strada!
Heartland – Into the Future – Recensione
08 Novembre 2021 24 Commenti Vittorio Mortara
genere: Hard Rock
anno: 2021
etichetta: Escape
Non vi nascondo che aspettavo questo album con apprensione. Gli Heartland sono stati, per me, una band di riferimento. Uno di quei pochi gruppi che hanno cominciato nell’epoca aurea, non si sono arresi nel ‘medioevo’, garantendo uscite puntuali e sempre di alto livello, e poi sono spariti dalle scene dopo l’album “Mind your head” del 2007. Un vuoto di 14 anni in cui il leader Chris Ousey ha continuato a comporre e cantare buona musica, da solo o con i vari Ozone, Distance e Snakecharmer. Però, vuoi per la rottura con il suo alter ego, il talentuoso chitarrista Steve Morris, vuoi per i budget sempre più limitati per le produzioni, la qualità generale di quelle uscite non ha mai neppure avvicinato quanto ascoltato nella terra del cuore. Ragion per cui, quando qualche mese fa la Escape ha annunciato questo disco, il mio, di cuore, ha avuto il classico sussulto. Cercando info qua e la, ho scoperto che Chris ha messo su una formazione nuova di zecca, prendendo al suo fianco il dotato chitarrista Mike Slamer (Streets, Steelhouse Lane, Seveth Key…) che lo ha coadiuvato anche nella stesura dei pezzi e nel mixaggio e produzione del platter. Il nome di Slamer mi ha fatto presagire due cose: un certo indurimento del sound, vista anche la presenza di due chitarristi di ruolo, ed una produzione di livello assoluto, cosa che, un po’, è sempre mancata nei vecchi dischi. E i presagi si sono avverati entrambi! Questo è un album Heartland al 100%! La voce di Chris è tale e quale a 20 anni fa. Timbro particolare, quasi abbaiato, e riconoscibile ad occhi chiusi. Il sound è fortemente british, profondamente radicato nella tradizione musicale di quella terra, mai sguaiato o tamarro. I pezzi sono confezionati alla perfezione, nei minimi particolari. E per tale motivo vanno ascoltati con attenzione. Possibilmente in formati audio di qualità, perché qui c’è tanta roba che è un vero peccato comprimere con algoritmi lossy. Se fino a questo punto a leggere vi siete fatti l’idea che questo sia un progetto a due, Ousey/Slamer, devo contraddirvi. Tutto il resto della band è assolutamente all’altezza: sezione ritmica inappuntabile e tastiere presenti ma mai invadenti. La formula a due asce è assolutamente vincente: il wall of sound che ne deriva è veramente grandioso! Il suono un po’ scarno della chitarra di Morris è stato sostituito da qualcosa di più “grosso” e gratificante per i padiglioni auricolari ed il sistema limbico di chi ascolta.
Andiamo con le canzoni. Apre il già noto singolo “Foreign land”, brano articolato di puro hard rock senza tempo, non facile sulle prime, ma ricco di pathos e passaggi mai scontati. “Caught up” è un pezzo 100% Heartland, ma con queste chitarre e questa chiarezza di suoni pare assai più hard di qualsiasi cosa ascoltata in passato. E Ousey ci mette del suo urlandoci in faccia l’antemico refrain prima dello stacchetto centrale rarefatto. Ingentilita dalle tastiere, “Living thing” è la massima concessione alle melodie easy dell’intero disco. Un bel semi lento che prende immediatamente al cuore. Sentite che meraviglia i ricami puliti o distorti delle due chitarre. Ed apprezzate la voce di Chris dominare in lungo e in largo l’intera composizione. Ancora un etereo giro di piano introduce “Giving it alla way”, ma subito viene doppiato dalla chitarrona di Slamer e di qui si snoda una canzone melodica e ricca di spunti, come il cambio di tempo che precede il bell’assolo di chitarra o il finale sfumato affidato ancora al piano. “Dangerous game” è un brano di hard pomposo nel quale l’intera band può esibire la propria tecnica individuale. Ma non crediate sia un pezzo ostico o fine a se stesso: la melodia è assolutamente piacevole pur non risultando affatto banale. Gronda Heartland-sound la seguente “Climbing your wall” rimbalzando fra melodie orecchiabili e ghirigori delle chitarre senza soluzione di continuità. Un po’ più canonico il mid tempo “Mouth to mouth”, brano di british rock semplice ma suonato con la consueta maestria. Il livello risale immediatamente grazie all’incedere maestoso di “Not guilty”, un crescendo che sfocia in uno splendido e potente chorus. Ritmi speed caratterizzano “Bolt from the blue” tanto che all’altezza dell’assolo pare un pezzo metal. “White lies” è decisamente il mio estratto preferito. Mi piace quella ritmica funkeggiante, adoro quel coretto sbarazzino e amo qell’assolo breve e tagliente. L’hard rock albionico ci viene somministrato ancora in massicce dosi sulla squadrata “Working for the man” quando un simil hammond vecchio stile accompagna i riff delle due chitarre. A chiudere degnamente l’album ci pensa, infine, “When the band plays”, così vicina al passato del gruppo da poter benissimo essere una outtake di “Miracles by design” o di “As it comes”.
Allora questo è il miglior disco degli Heartland dal 1990 ad oggi? Forse… Dove invece non ci sono dubbi è sul fatto che sia quello meglio prodotto e meglio suonato in assoluto. Steve Morris è un bel chitarrista, è innegabile. Ma il valore del suo strumento, a mio giudizio, è stato sempre un po’ penalizzato dai mix e dalle registrazioni. Così come la qualità complessiva dei suoni. L’avvento di Slamer ha corretto completamente questa pecca. Adesso tutto scaturisce dalle casse con le giuste proporzioni. Si sentono i particolari. Si apprezzano le sfumature. Il sound si è fatto decisamente più metallico. Invariata, invece, la qualità delle composizioni, sempre di valore assoluto. E senza dover cercare idee o ispirazioni da nessun altro! Chi vi scrive non è il più imparziale dei recensori e nemmeno si è mai vantato di esserlo, per cui mi sento libero di affermare che per me questo è uno dei dischi più belli che si siano ascoltati in questo 2021. Coinvolgenti gli Eclipse, innovativi i Reach e i Seventh Crystal, sorprendenti Chez Kane ed i Nestor. Ma quando la tua classe arriva dagli anni 70, quando le tue radici affondano nei Deep Purple e nella Bad Company, quando i tuoi trascorsi si chiamano Virginia Wolf e Streets, il risultato è qualcosa che non può che sbaragliare in un colpo solo tutta la concorrenza.
Io la mia copia autografata me la sono comprata. Fate altrettanto e non ve ne pentirete!
Out Of This World – Out Of This World – Recensione
05 Novembre 2021 12 Commenti Vittorio Mortara
genere: Aor
anno: 2021
etichetta: RCA/Victor Japan
Con colpevole ritardo dovuto a qualche disguido tecnico, vi proponiamo il secondo disco per i Kee of Hearts della strana coppia Kee Marcello/Tommy Heart… oops… scusate ma non si chiamano più Kee of Hearts bensì Out Of This World, come il pluriplatinato disco degli Europe di fine anni 80. La sostanza non cambia. E I musicisti cambiano poco. I nostri eroi sono supportati dalla validissima sezione ritmica composta da Ken Sandin e Darby Todd, mentre a dar man forte alle tastiere è stato scritturato addirittura il mostro sacro Don Airey. Neppure la proposta varia di molto rispetto al debutto: come l’aveva descritta in maniera perfetta il capo Denis, la musica che fluisce dai solchi di questo LP come da quelli del precedente è il perfetto mix tra l’hard melodico tedesco e l’AOR di matrice scandinava.
Insomma, i Fair Warning infarciti dagli inconfondibili assoli di Marcello che sembrano arrivare pari pari dalle session del già citato album degli Europe. Rispetto al primo, però, su questo album trovano più spazio le magniloquenti tastiere di Airey e il tutto asume un’aria più pomposa. Forse persino troppo… Come si percepisce già dall’opener “Twilight”, un filo stucchevole. Meglio la più hard “Hanging on” che piace per il suo coro ridondante. Il giro di keys che apre “In a million years” deve parecchio a “Open your heart” e persino la voce di Tommy fa un po’ il verso a quella di Tempest. Però tutto sommato, il pezzo è buono. Un’altra intro pomp accende “Lighting up my dark”, brano da repertorio Fair warning, caratterizzato dai licks della solista di Kee. Bella canzone anche “Staring at the sun”, con un ritornello che cattura ineluttabilmente. Il profumo dei Mr.Big pervade profondamente “The warrior”, up tempo tecnicissimo. Ancora Europe in “Up to you”, stavolta periodo “Prisioners in paradise”. Così come la gradevole “Ain’t gonna let you go” torna alla navicella madre del gruppo tedesco. Il finale dell’album è consegnato ad un’accoppiata di lenti: “Only you can teach me how to love again”, molto corale e dall’aria solenne, e “Not tonight” proposta anche in veste acustica in alcune versioni dell’album, un pelo più leggera.
Com’è allora questo disco? Beh, intanto c’è da premettere che la voce di Tommy Heart sembra non avere perso lo smalto dei bei tempi: il suo timbro maschio e hard caratterizza, anzi, valorizza qualsiasi pezzo in cui metta becco. Kee Marcello non lo scopriamo oggi: la sua tecnica è ben al di sopra della media ed il suo gusto per la melodia è innegabile. Quello che convince poco me è l’ispirazione compositiva. I pezzi, come ho già detto, sono un mix di Europe e Fair Warning ma non raggiungono l’eccellenza di quelli delle band originali. Per di più in questo album alcune partiture di tastiere, sempre a giudizio di chi vi scrive, sembrano un po’ appiccicate lì giusto per gratificare l’illustre ospite alle tastiere. Nota di merito per la produzione affidata a Ron Nevison (grazie ai soldini della Victor?) che riesce a tirare fuori un sound pulito e scintillante come piace a noi. Nel complesso, quindi, il lavoro non è male e si lascia ascoltare con piacere. Se potete, procuratevi l’edizione con l’extra dell’intera esibizione dei Kee of Hearts all’ HEAT Festival del 2018 alla quale il sottoscritto era immancabilmente presente, così potrete anche voi crogiolarvi nella riproposizione dei grandi classici del passato… Buon Ascolto!
Memoria Avenue – Memoria Avenue – Recensione
05 Novembre 2021 0 Commenti Yuri Picasso
genere: Aor
anno: 2021
etichetta: Frontiers
Nuova proposta norvegese in casa Frontiers, dal moniker suggestivo che richiama un flemmatico viaggio lungo la costa durante un esteso e caldo tramonto. Componenti non nuovi alle latitudini di noi estimatori del genere; la mente è Tor Talle (Northern Light, collaboratore in studio di Tony Mills, Steve Overland, Rob Moratti, tra gli altri), affiancato dal duo Dag Selboskar e Bjørn Olav Lauvdal (Tastiere e Batteria dei Da Vinci), dal basso di Svenn Huneide e capeggiati dal timbro nordico ma suadente di Jan Le’Brandt, alla prima come lead Singer.
La proposta musicale vede le maggiori influenze in acts quali Journey, Stage Dolls, Street Talk, Bad Habit, gli stessi Da Vinci ovviamente. Una proposta collaudata, intrinseca di melodia e amorevoli propositi. Il lotto di canzoni risulta omogeneo mancando di toccare vette compositive proprie alle band cardine sopra citate, escludendo al medesimo tempo pezzi carenti di armonie affini ad un confortevole abbraccio. In questo senso il singolo “Stuck” è un esempio perfetto. Incidere calzante, dinamiche alternate, assolo in pentatonica. Nulla di nuovo o rivoluzionario, ma straordinariamente accogliente. “Can’t Blame It On The Rain” dalla raffinata ritmica accende ricordi positivi; “Nathalia” profuma di Dalton con pregevoli varianti di dinamica; “Sometimes” è davvero riuscita, romantica sognante ed immediata. “Run With Me” alza il basso livello adrenalinico se non fosse per un ritornello similissimo alla “Hot Cherie” degli Hardline. Si ritorna in confort zone con “If You Fall” che, oltre per il titolo, ricorda per struttura e sviluppo qualcosa dei primi W.E.T.
Riconoscendo alla band la capacità di arricchire con ogni mezzo a disposizione ciascun arrangiamento presente in scaletta, l’eccessivo livellamento dei brani non permette al disco di raggiungere un voto maggiore che forse, per lo sforzo profuso in fase di composizione, avrebbe meritato. Come l’effetto di una cioccolata calda d’inverno, questo esordio targato Memoria Avenue rassicura
e riscalda con una ricetta nota e ineccepibilmente riprodotta.
Newman – Into The Monsters Playground – Recensione
04 Novembre 2021 4 Commenti Samuele Mannini
genere: Melodic Rock/ Aor
anno: 2021
etichetta: Aor Heaven
Tredicesimo studio album per Steve Newman ed il suo omonimo progetto oramai attivo dal lontano 1997. Dopo la pandemia che ha sconvolto i piani di tutta l’attività live che avrebbe dovuto supportare il precedente Ignition, la decisione di sfruttare questo periodo per comporre e realizzare questo Into The Monster Playground è stata una naturale conseguenza.
Una copertina con un minaccioso uragano ci introduce queste dodici canzoni che non si discostano affatto dal trademark tipico del polistrumentista e singer britannico. Un melodic rock/Aor soffuso, che poggia su un soffice tappeto tastieristico, ma che non disdegna le sortite chitarristiche dal taglio deciso , il tutto arricchito dalla voce con un piglio deciso ed atmosfere tal taglio vagamente Survivor, non disdegnando comunque rimandi al melodic rock più moderno di impronta nord europea.
Questo disco non può e nemmeno vuole, essere quindi dedicato a chi ama sperimentazioni sonore, ma anzi rappresenta un porto sicuro per gli amanti della melodia classica e senza tempo. Prova ne sono canzoni come l’opener Start This Fire, classica canzone da apertura per scaldare l’ambiente e far capire quale sarà l’andazzo. Pregevole fattura anche per la catchy Hurricane Sky e la lenta e romantica Lightning Tree. Un vago rimando all’ hard rock degli eighties in Don’t Come Running, con le sue sonorità Silent Rage. Infine, menzione per la particolare e conclusiva This Life Alone, sempre in bilico tra la delicatezza delle tastiere e gli inserti serrati di chitarra.
Ribadisco dunque, quelli a cui piacciono queste sonorità troveranno gradevoli conferme. Personalmente, trovo che anche il livello produttivo e sonoro sia di livello superiore al predecessore, potrebbe dunque essere anche una piacevole scoperta per chi fin ora non li aveva mai presi in considerazione. Per chi invece non si trova a suo agio con questo tipo di sonorità o cerca cose che esulano dai canoni classici del genere, non sarà certamente questo disco a far mutare la loro opinione.
Arthur Falcone’ Stargazer – Straight To The Stars – Recensione
02 Novembre 2021 4 Commenti Giorgio Barbieri
genere: Melodic Heavy Metal
anno: 2021
etichetta: Elevate Records
Mi sono avvicinato a questo secondo album a nome Arthur Falcone’ Stargazer, terzo se si considera “Stargazer” del 1998, uscito solo a nome di Arthur con le migliori intenzioni e speranze, nonostante io non sia, usando un eufemismo, un fan sia del power neoclassico, che dello shred a tutti i costi, non fosse altro che il chitarrista triestino ha un background di tutto rispetto, iniziando a 17 anni come autodidatta, passando poi per l’ultima incarnazione degli Halloween di Udine, quella più glam, quindi negli anni novanta gira in lungo e in largo l’Europa, suona con Vinnie Moore, apre per i Deep Purple allo stadio Grezar di Trieste, partecipa al Gods of Metal italiano e suona con Ian Paice, quindi scollina il millennio supportando John Lawton, suonando con Andrea Braido e Kiko Loureiro, quindi pubblica “The genesis of the prophecy” nel 2009 e fa da supporto agli L.A.Guns, prima di arrivare ai giorno nostri con questo “Straight to the stars” uscito per Elevate Records il 22 Settembre 2021, infine è giusto segnalare che Arthur è un insegnante di chitarra e uno dei suoi allievi più famosi è Luca Turilli, ex chitarrista dei Rhapsody e attualmente dei Turilli/Lione’s Rhapsody.
L’album ha una peculiarità, rispetto a molti prodotti dei virtuosi delle sei corde, ha tutti pezzi cantati se si esclude l’intro “The cradle” la forma canzone è un segno distintivo, ha però anche qualche difetto di questi album, il primo è il sentore di “già ascoltato”, non che ultimamente in tutto lo scibile hard’n’heavy si brilli di originalità, ma pezzi come la veloce “Secret of Roswell”, la melodica “Gypsy lady” o la più canonica “Sirens of darkness”, possono essere riportate ad un qualsiasi album di Malmsteen o degli Stratovarius, il secondo è l’uso della voce, io ho sempre preferito una “band” ad un progetto, quindi, nel bene o nel male, nel cantato di un frontman che caratterizzi l’opera , in questo caso, la differenza di ugole è evidente e non tutti i pezzi ne giovano, come credo che Arthur abbia pensato, in particolar modo nei due già citati “Gypsy lady” e “Sirens of darkness”. Certo, in toto, il disco è buono, “The only one” e la title track, che ha il valore aggiunto di Goran Edman alla voce, sono due pezzi molto catchy, potenzialmente due singoli azzeccati, tutti e due in chiave melodic metal anni 80, “Black fairy” è la mia preferita, un bel metal classico, una cavalcata degna del miglior Malmsteen, ma con qualcosa anche di David Chastain, “Paradise” sa sì di Stratovarius periodo d’oro, ma l’assolo di Arthur, a mio parere quello fatto con più gusto e meno strizzate d’occhi alla tecnica, è qualcosa di sublime, quindi “Distant star”, ballad semiacustica d’atmosfera cantata molto bene, infine le due covers, “Soldier of fortune” dei Loudness periodo Mike Vescera e “I’ll see the light tonight” di Malmsteen, non tolgono e neppure aggiungono agli originali, ma servono ad Arthur per dare, se ce ne fosse stato ancora bisogno, sfoggio della sua notevole bravura.
Chiudendo, “Straight to the stars” è un album che farà la felicità di tutti quelli che dormono con il santino di tutti gli shredder neoclassici sul comodino, ma anche chi apprezza il metal melodico anni 80, non sarà un capolavoro, alcune cose, come detto, non funzionano proprio e fanno perdere vigore al disco, ma non si può non apprezzare lo sforzo tecnico e compositivo di Arthur, vecchio leone di casa nostra, che comunque, ruggisce ancora.