LOGIN UTENTE
Registrati a MelodicRock.it

Registrati gratuitamente a Melodicrock.it! Potrai commentare le news e le recensioni, metterti in contatto con gli altri utenti del sito e sfruttare tutte le potenzialità della tua area personale.
effettua il Login con il tuo utente e password oppure registrati al sito di Melodic Rock Italia!
Classici
- Home
- /
- Classici
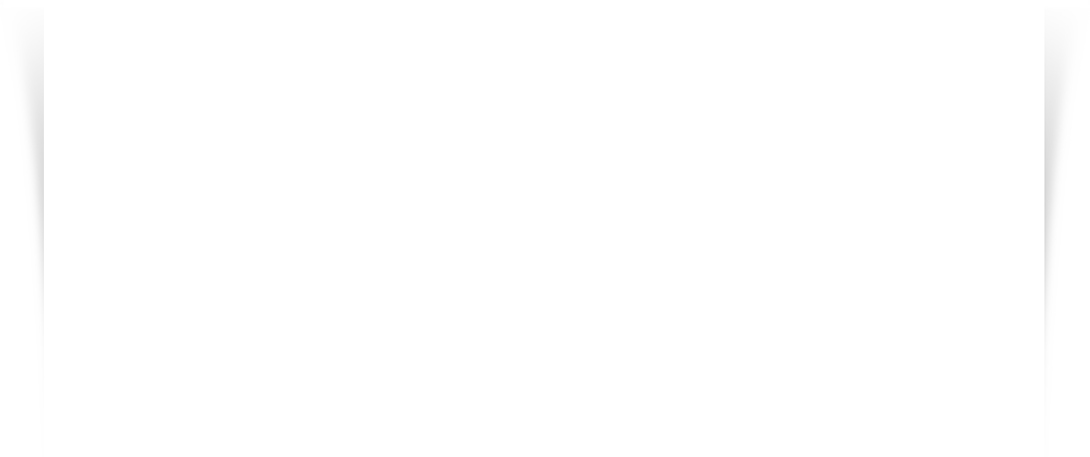
Shy – Excess All Areas – Classico
01 Febbraio 2025 0 Commenti Samuele Mannini
genere: Hard Rock/AOR
anno: 1987
etichetta:
ristampe:
Gli Shy sono un esempio emblematico di come molte band inglesi degli anni ’80 abbiano cercato di conquistare il mercato musicale statunitense durante l’era dell’hard rock. Nonostante il loro talento e la loro energia, come molti altri gruppi, hanno incontrato difficoltà nel mantenere una presenza stabile negli Stati Uniti. Questo fenomeno era comune a molte band che, pur avendo successo in Europa, trovavano il mercato americano particolarmente competitivo e difficile da penetrare, e si possono citare altri esempi, come Thunder e FM.
Non possiamo dimostrare se ciò fosse dovuto al fatto che le band britanniche portavano con sé un certo ‘sapore’ culturale, che poteva non risuonare immediatamente con il pubblico americano, abituato a modelli e riferimenti differenti, o all’ostracismo delle major discografiche, quasi tutte americane, che tendevano a promuovere maggiormente le band locali. Tuttavia, questo fenomeno ha reso estremamente difficile per le band inglesi ottenere riconoscimenti oltreoceano, portandole spesso a conformarsi a tendenze musicali non sempre in linea con la loro identità artistica.
Gli Shy si erano però ben preparati a tentare lo sbarco, e infatti la scelta di avvalersi di songwriter come Michael Bolton e Don Dokken appariva adeguata per sdoganare il British sound nelle Colonies. C’è da dire che nessuno sforzo era stato lesinato nemmeno nella impeccabile produzione, curata da Neil Kernon, e nella qualità sia delle composizioni sia delle esecuzioni.
Dopo gli esordi con “Once Bitten…Twice…Shy” (1983) e “Brave The Storm” (1985), la band ha dunque pubblicato quello che è considerato il loro capolavoro, presentando un AOR robusto e moderno, con un mix di hard rock melodico e influenze classic metal. Musicalmente parlando, la chitarra di Steve Harris è melodica e precisa, e si sposa alla perfezione con la voce di Tony Mills, che ha un po’ il timbro di Geoff Tate, con quella potenza e quella profondità emotiva. La sua malinconia aggiunge un tocco speciale sia nei pezzi più energici che nelle ballad. In più, le tastiere di Paddy McKenna fanno un lavoro incredibile, creando atmosfere epiche e quasi da film di fantascienza, che danno una marcia in più al sound.
Il disco si distingue per una serie di brani significativi che mostrano la versatilità della band. “Emergency” apre con un potente equilibrio tra chitarre e synth, scritto in collaborazione con Michael Bolton. Tra le tracce più memorabili c’è “Break Down The Walls”, scritta con Don Dokken, che emerge come la hit dell’album, grazie a un riff irresistibile e a un’atmosfera tipica degli anni ’80. “Young Heart” porta un tocco di AOR con melodie sinuose e un ritornello che rimane impresso, mentre “Devil Woman”, una rivisitazione in chiave melodic hard rock della celebre canzone di Cliff Richard, si fa notare per i cori irresistibili e i riff corposi. A completare il quadro, “When The Love Is Over” è una ballad strappalacrime, arricchita da soavi accompagnamenti di tastiera, e viene considerata una delle ballad AOR più belle di tutti i tempi. Questa lista di brani dovrebbe essere già sufficiente a farvi correre a comprare “Excess All Areas”, qualora non lo abbiate già, ma sono sicuro che a nessuno dei nostri lettori manchi questo disco nella propria collezione.
Stiamo dunque parlando di un vero e proprio oggetto di culto per gli amanti dell’AOR, grazie alla sua qualità musicale e alla sua energia. Lo considero un punto di riferimento per il genere e uno dei tanti esempi di come il rock britannico possa competere con quello americano, a volte superandolo grazie a quel tocco british che magari fa storcere il naso agli americani, ma che denota un background culturale che oltreoceano possono solo sognare. Nonostante la scomparsa di due membri chiave, Steve Harris e Tony Mills, l’eredità degli Shy e di “Excess All Areas” rimane intatta. Questo lavoro è un vero gioiello per chi ama l’AOR e il melodic hard rock, un esempio di come passione e talento possano creare un’opera d’arte senza tempo.
Se amate l’AOR con una marcia in più, “Excess All Areas” è un acquisto obbligato.
Beggars & Thieves – Beggars & Thieves – Gemma Sepolta
31 Gennaio 2025 0 Commenti Samuele Mannini
genere: Hard Rock/AOR
anno: 1990
etichetta:
ristampe:
Ancora un disco del 1990? Eh sì, non so se avete notato cosa diavolo è uscito nei primi tre anni dei famigerati Nineties in ambito Hard Rock, AOR ed affini. Come se fossero gli ultimi istanti di un amplesso, tutto il carico maturato nel decennio precedente è stato rilasciato in un estatico e pirotecnico finale, prima di abbandonarsi allo sfinimento e alla stanchezza post-coitale. Questi tre anni meriterebbero una retrospettiva particolareggiata e approfondita… e non è detto che prima o poi non mi decida a farla, ma nel frattempo occupiamoci dei Beggars & Thieves.
Nel 1990, mentre il grunge iniziava a farsi strada, i Beggars & Thieves pubblicavano il loro album di debutto omonimo, un gioiello di hard rock/AOR che, ovviamente dato il periodo, non ottenne il successo meritato. Questo disco, uscito per Atlantic, si rivela ancora oggi un capolavoro per gli appassionati del genere, un vero e proprio baluardo dell’hard rock più evoluto e variegato partorito in quegli anni. La band, composta da Louie Merlino alla voce, Ronnie Mancuso alla chitarra, Phil Soussan al basso e Bobby Borg alla batteria, vantava già un pedigree di tutto rispetto, con membri che avevano suonato con leggende come Jimmy Page, Ozzy Osbourne e Dio.
L’album si apre con “No More Broken Dreams”, un brano che parte con un’intro orientaleggiante (chi ha detto Kashmir?), per poi esplodere in un hard melodico di grande impatto. La voce di Merlino, che a grandi tratti può essere sintetizzata in un misto tra Paul Stanley e Robert Plant, guida l’ascoltatore attraverso un viaggio sonoro che mescola influenze classiche con un tocco assai più personale. In “Billy Knows Better” si viene incalzati da un riff chiaramente zeppeliniano e un assolo bluesato, mentre “Waitin’ For The Man” introduce un blues elettrico con un refrain ai limiti del glam. “Your Love Is In Vain” è un mid-tempo lento e intenso, impreziosito da timbriche di chitarra sature, ma con un coro che non avrebbe sfigurato su un disco del Michael Bolton più pop, mostrando la versatilità della band.
“Isn’t It Easy” e “Let’s Get Lost” mantengono alta la qualità, con atmosfere che richiamano più quell’AOR maturo proposto in quegli anni anche dai Giant. “Heaven & Hell” è caratterizzata da un riffing più funky ma con un’anima blues che viene sfoderata nel solo di chitarra. In “Love Junkie” spunta l’onnipresente (ai tempi) penna di Desmond Child, ed ecco che si punta sul ritornello catchy ed anthemico, che solo due o tre anni prima sarebbe valso la top di Billboard. “Kill Me” è l’immancabile power ballad intensa e strappamutanda con la quale noi giovinastri dell’epoca tentavamo di far colpo sulle pulzelle ancora in qualche modo attratte dal rocker romantico. “Love’s A Bitch” è un glam losangelino quasi da manuale, con un riff poderoso e un cantato ammiccante. La title track “Beggars and Thieves” conclude infine l’album con una gradevole ballad semi-acustica.
La produzione di Steve Thompson e Michael Barbiero è ovviamente impeccabile e dona all’album un suono potente e definito, che ai giorni nostri esiste solo nel mondo dei sogni. Gli arrangiamenti sono semplici e di buon gusto, assolutamente mai banali, miscelando le atmosfere del rock americano con toccate di blues ed echi glam. Il risultato è un sound riconoscibile ma assolutamente unico. Ogni brano è curato nei minimi dettagli, con riff immediati ma eclettici, assoli chirurgici e melodie accattivanti. Le ballate, inoltre, non seguono i soliti cliché ma puntano tutto sul sentimento, generando un pathos che non può lasciare gli ascoltatori indifferenti.
Nonostante l’evidente qualità, l’album non ricevette l’attenzione che meritava, creando una sorta di mistico alone di culto intorno alle copie di questo disco, specie in edizione vinilica.
In conclusione, Beggars & Thieves è un album che merita di essere riscoperto e apprezzato. È un vero peccato che una band di tale talento sia stata ignorata al momento della sua uscita. Questo disco è l’ennesima prova lampante di come la qualità non sempre trovi il giusto riconoscimento. La band ha successivamente sfornato negli anni altri lavori di spessore, dando prova di una straordinaria resilienza al tempo che passa, ma inutile dirlo: la magia che era presente qui è semplicemente irripetibile, perché figlia di un’epoca ormai passata.
Trouble Tribe – Trouble Tribe – Gemma Sepolta
29 Gennaio 2025 1 Commento Samuele Mannini
genere: Hard Rock
anno: 1990
etichetta:
ristampe:
Correva l’anno 1990 e il mondo del rock si trovava a un bivio. Il grunge iniziava a ribollire nel sottobosco di Seattle, mentre il glam metal, ancora aggrappato ai suoi eccessi fatti di capelli cotonati, riff roboanti e testi sfacciati, stava vivendo i suoi ultimi lampi di gloria. In questo scenario, che destino poteva avere una band che suonava il genere ‘sbagliato’ e che addirittura proveniva dal lato ‘sbagliato’ degli USA? Ecco a voi una band che ha brillato per un solo intenso attimo, i Trouble Tribe.
Il loro unico album omonimo, pubblicato dalla Chrysalis Records, è un concentrato di energia, melodia e virtuosismo. Una perla che, come spesso succedeva all’ epoca, non ha trovato il successo che meritava, ma che mi rimanda a quando la mattina sull’ autobus che mi portava alle superiori cantavo a squarciagola le canzoni di questo album tra lo sbigottimento generale degli astanti.
L’album si apre con una coppia di brani killer: “Tattoo” e “Here Comes Trouble”, entrambi accompagnati da videoclip martellanti su MTV, progettati per proiettare la band nell’olimpo dell’ hair metal. “Tattoo” è praticamente da manuale per il genere: apertura con voce synth di bonjoviana memoria, riff accattivante, ritornello irresistibile e una produzione scintillante. È uno di quei pezzi che ti immagini urlare con i finestrini abbassati, capelli al vento ovvero il biglietto per la gloria, purtroppo, mancata.”Here Comes Trouble”, tira fuori un’anima più sporca, con un groove cadenzato e pulsante che richiama i momenti migliori di band come i Ratt o Dokken. È un manifesto di ribellione che sembra perfetto per una generazione ancora affamata di edonismo. Ma i Trouble Tribe non sono solo una band da party e anthem da stadio. C’è una profondità sorprendente nel loro lavoro. Prendiamo “Gimme Something Sweet”, ad esempio. Con il suo intro bluesy, il brano si tuffa in territori inaspettati, dimostrando che i ragazzi non temevano di giocare fuori dal loro campo di comfort. Poi siccome il manuale del genere richiede una power ballad ecco che arriva “In The End”, ed è da applausi a scena aperta e accendino sventolante.E che dire di “Back To Wall”? Il suo assolo di chitarra, firmato da Adam Wacht, è un momento da brividi, di quelli che non avrebbero sfigurato in un album degli Whitesnake era Sykes. Per chi cerca pura adrenalina, “Boys Nite Out” è un inno al divertimento sfrenato, un invito a vivere la notte al massimo. È il tipo di canzone leggera e danzereccia che trasuda energia da festa, il carburante perfetto per un weekend senza fine.
Ma l’album non è tutto luci stroboscopiche e sorrisi smaglianti. “Tribal Beast”, un brano strumentale, introduce un’atmosfera più oscura, quasi inquietante. È un cambio di registro che prepara il terreno per la potente “Red Light Zone”, un pezzo che picchia duro senza rinunciare alla melodia. “(Angel With A) Devil’s Kiss” chiude il cerchio, con un sound tagliente e ruvido che riporta alla mente i Dokken più aggressivi.
Nel bel mezzo di questo caleidoscopio di riff e adrenalina, spunta una cover inaspettata: “Dear Prudence” dei Beatles. Una scelta coraggiosa e quasi spiazzante per una band glam, ma che dimostra il coraggio dei Trouble Tribe. Pur non raggiungendo le vette dell’originale, questa reinterpretazione conferisce al brano una personalità nuova e un’intensità che lo rende una chicca interessante. Il disco si chiude con “F’s Nightmare”, un breve strumentale che lascia l’ascoltatore con la voglia di voler ricominciare tutto da capo.
Uno degli aspetti più eclatanti di questo album è la produzione, impeccabile e tipica degli anni ’80, con un mix pulito che esalta le performance della band, cose che, ai giorni nostri, possiamo soltanto ricordare con nostalgia.
Per quanto riguarda l’esecuzione, Jimmy Driscoll, con la sua voce potente ed espressiva, riesce a passare senza sforzo da momenti graffianti a toni più morbidi e sentimentali, mentre Adam Wacht, alla chitarra, firma riff catchy e graffianti ed assoli che strizzano l’occhio ai grandi virtuosi dell’epoca.
La sezione ritmica, composta da Eric Klaastad al basso e Stephen Durrell alla batteria, fornisce una base solida e dinamica che regge il peso di ogni traccia.
Purtroppo, i Trouble Tribe non sono mai riusciti a raggiungere il successo che meritavano. Forse il declino dell’ hair metal, forse una promozione poco incisiva o semplicemente il tempismo sbagliato li hanno relegati a un ruolo di culto. Eppure, a distanza di trent’anni, il loro album conserva tutta la freschezza e l’energia di allora. È un disco che cattura lo spirito dell’epoca nella sua forma più pura e se sei un fan del genere o semplicemente un amante delle gemme sepolte, i Trouble Tribe meritano una bella rispolverata, e poi ditemi che una copertina del genere non invoglia all’acquisto 😉 .
Dopotutto, la vera grandezza non ha bisogno di classifiche per brillare. I Trouble Tribe ne sono una prova vivente.
Royal Hunt – Moving Target – Classico
05 Gennaio 2025 5 Commenti Samuele Mannini
genere: Melodic Metal
anno: 1995
etichetta:
ristampe:
Negli anni ’90, le uscite di AOR e Hard Rock melodico si trovavano col lumicino, quindi, sentendomi in carenza di nuovi dischi, cercavo nei versanti più melodici del metal per trovare qualcosa che stimolasse la mia voglia di scoperta. Erano gli anni del power metal e il panorama musicale del 1995 seguiva molto questo filone. Nel frattempo, mi ero votato parecchio al sound degli Stratovarius quando vidi su Flash una recensione, scritta da tal SN, di uno sconosciuto (almeno a me) gruppo danese, a cui avevano assegnato un roboante 90. La recensione (di cui conservo un ritaglio) citava Queen, Styx e Symphony X, con commistioni tra musica classica e metal nordico, ingredienti perfetti per accendere la mia curiosità.
Moving Target rappresenta l’album della svolta per i Royal Hunt. Nei precedenti lavori, la band si muoveva in territori più vicini all’hard rock, integrando elementi sinfonici che, tuttavia, non venivano pienamente valorizzati. Questo scenario cambia radicalmente con l’arrivo del cantante americano DC Cooper, il cui timbro e straordinaria estensione vocale hanno permesso al gruppo di esplorare una direzione sonora più articolata e completa. Ne è risultato un sound che unisce elementi barocchi della musica classica, tanto cari al tastierista e songwriter André Andersen, a ritornelli memorabili, in grado di creare il perfetto hook per catturare l’audience giapponese. Non a caso, l’album ha riscosso un enorme successo in Giappone, vendendo oltre 200.000 copie.
Lungo l’intero disco si percepisce una raffinata fusione di influenze: dal metal melodico scandinavo agli arrangiamenti pomp, che arricchiscono il sound senza appesantirlo, donandogli una lucentezza abbagliante. A ciò si aggiunge un concept profondo e universale, che invita l’ascoltatore a riflettere su tematiche sociali, come il rapporto tra l’uomo e Dio, la violenza e la sofferenza, e la ricerca di un significato nella vita.
Anche la copertina dell’album ha una storia significativa: raffigura le rovine dell’Institut Jeanne d’Arc, una scuola cattolica francofona a Copenaghen distrutta accidentalmente durante un bombardamento della RAF nel marzo del 1945. Sebbene l’obiettivo del raid fosse il quartier generale della Gestapo, alcune bombe colpirono edifici vicini, tra cui la scuola. L’immagine riflette perfettamente il messaggio dell’album: nella vita, tutti siamo potenzialmente bersagli delle avversità.
Ogni brano è un viaggio emotivo, guidato dalla voce potente di D.C. Cooper e dagli arrangiamenti maestosi di André Andersen.
Si comincia con “Last Goodbye”, un uomo si ritrova solo, perso nell’incubo della dipendenza, con l’eco di un addio che risuona nella sua mente. La sua preghiera disperata, rivolta a un cielo che sembra distante, si leva come un ultimo barlume di speranza. Il brano si apre con un’introduzione orchestrale evocativa creata con la tastiera di Andersen, e culmina in un assolo mozzafiato che lascia un senso di struggente malinconia. La lettura del Padre Nostro lega questo “ultimo addio” con la seguente “1348”, un’ombra oscura si allunga sull’Europa, dove la peste nera miete vittime, trasformando città fiorenti in cimiteri silenziosi. La voce di Cooper si eleva in un lamento straziante, dipingendo un quadro apocalittico di un mondo in preda al caos. Le tastiere di Andersen creano un’atmosfera tetra e opprimente, amplificando il senso di tragedia.
“Makin a Mess” è una cavalcata che parla di un soldato catapultato nella battaglia e del suo animo, che si trova ottenebrato da questo incubo di violenza che prende il sopravvento su ogni cosa.
“Far Away” è una power ballad da manuale struggente inno a coloro che ci hanno lasciato troppo presto, celebrando così il legame eterno del sentimento.
“Step By Step” a dispetto del suo incedere allegrotto e funky, narra di un viaggio nel degrado a cui passo dopo passo, purtroppo, ci abituiamo.
“Autograph” è un brano strumentale dove Andersen sfoggia tutta la sua tecnica e le sue influenze e funge da intermezzo legandosi quasi naturalmente a “Stay Down” che si distingue per la sua spontaneità emotiva e la sua crudezza, riflettendo la disillusione e la disperazione raccontate nel testo.
Nell’inizio di “Give it Up” io avverto echi Queensrÿche, anche se poi la canzone si svolge con immediatezza riflettendo la disillusione che pervade il testo.
Chiude la trionfale cavalcata di “Time” che sintetizza gli elementi del metal più sinfonico presenti nel disco e l’eleganza delle melodie trattando del tempo e dell’uso non sempre ideale che gli esseri umani ne fanno.
Insomma, cosa volere di più nel 1995? Melodia, tecnica, arrangiamenti sublimi e un uso magistrale dei cori per un disco che non solo ha surrogato la carenza di rock melodico di quegli anni, ma ha anche aperto una nuova finestra su un genere meraviglioso. Un disco che ha avuto la capacità di unire sia il metallaro più duro che il meldiomane più accanito, ma in fondo so benissimo che piace anche a moltissimi di voi.
Dokken – Back For The Attack – Classico
21 Dicembre 2024 2 Commenti Samuele Mannini
genere: Hard Rock
anno: 1987
etichetta:
ristampe:
Come tutte le questioni trattate sull’italico suolo, quando si parla dei Dokken ci sono sempre i Guelfi e i Ghibellini, o nel caso specifico, gli ‘Attackisti’ e i ‘Lockiani’, ovvero chi preferisce “Back For The Attack” o “Under Lock And Key”. Cercherò di spiegare perché, per chi vi scrive, questo sia il disco migliore, cercando di uscire dalla lotta di fazioni per partito preso.
L’album si apre con la travolgente “Kiss of Death”. Fatico a ricordare un pezzo di apertura di un disco altrettanto efficace: un inno hard rock che affronta il tema dell’AIDS con un’intensità sorprendente per l’epoca. “Prisoner” è un brano più introspettivo, con un’atmosfera cupa e un assolo struggente di Lynch. “Night by Night” e “Standing in the Shadows” sono due inni hard rock energici, con riff accattivanti e melodie orecchiabili che danzano sul sottile filo che separa e allo stesso tempo unisce l’hard rock e l’heavy metal. “Heaven Sent” è una power ballad di grande impatto, con un’interpretazione vocale intensa di Dokken e un assolo di Lynch che bilancia potenza e melodia. “Mr. Scary”, la strumentale dell’album, è un’esplosione di virtuosismo chitarristico, con Lynch che si scatena in un vortice di assoli e riff complessi, dando sfoggio di tecnica e feeling.
L’album rimane un testamento del talento di un gruppo che, nonostante i suoi demoni interiori e qualche critica per la sua eccessiva lunghezza, ha saputo lasciare un segno indelebile nella storia dell’hard rock, coniando il sound tipico che sarà poi definito come Class Metal e al quale, da lì in avanti, miriadi di band si ispireranno.
Per chi scrive dunque, Back For The Attack resta il vertice artistico dei Dokken, capace di coniugare potenza, melodia, virtuosismo ed alcuni brani da tramandare alla storia. Ed è proprio questo equilibrio a renderlo superiore a Under Lock And Key, ma lasciamo pure che la battaglia tra ‘Attackisti’ e ‘Lockiani’ continui, perché comunque sia, entrambi rappresentano un’eredità indelebile nella storia del rock.
Only Child – Only Child – Gemma Sepolta
14 Dicembre 2024 5 Commenti Samuele Mannini
genere: AOR
anno: 1988
etichetta:
ristampe:
Paul Sabu è una figura quasi mitologica nell’universo dell’AOR e del melodic rock. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con grandi nomi della musica come Paul Stanley, Sammy Hagar, Joe Lynn Turner e Blackie Lawless. Oltre a essere un musicista e cantante di talento, Sabu si è distinto come talent scout, scoprendo band come i Silent Rage e le Precious Metal, senza contare le sue numerose produzioni e il suo naturale talento nel songwriting. La sua vasta esperienza ha dato vita a capolavori indimenticabili, tra cui spicca “Only Child”, un album che fin dalla sua uscita ha mostrato le caratteristiche di un classico in divenire.
Pubblicato nel 1988, “Only Child” fu accolto con entusiasmo dalla critica e venne inserito da *Kerrang!* tra i 40 migliori album AOR di sempre, ottenendo l’eccezionale valutazione di “L”, superiore alla tradizionale scala di cinque “K” usata dalla rivista. Questo riconoscimento sottolinea il valore di un disco che cattura l’essenza del sound anni ’80, con un hard rock melodico sofisticato e accattivante, prodotto che sarebbe dovuto essere perfetto per le radio dell’epoca.
La produzione è impeccabile, con le chitarre di Sabu intrecciate magistralmente alle tastiere di Tommy Rude, creando un tappeto sonoro coinvolgente e dinamico. La sezione ritmica, composta da Murril Maglio al basso e Charles Esposito alla batteria, fornisce una base solida e potente che esalta le melodie.
La voce di Sabu è il vero punto di forza dell’album: potente, versatile e capace di modulare la sua intensità per adattarsi ad ogni brano. Con una timbrica che richiama spesso e volentieri il Coverdale più sanguigno, Sabu alterna toni aggressivi a momenti di grande dolcezza, evitando eccessi e offrendo interpretazioni equilibrate e appassionate. Questa capacità rende ogni canzone un piccolo capolavoro.
Le tracce del disco offrono una varietà stilistica accompagnata da una qualità costante. Prendiamo ad esempio “Always”, un mid-tempo elegante e trascinante, con un ritornello che si imprime nella mente fin dal primo ascolto. Proseguendo, si incontra l’energia contagiosa di “I Wanna Touch”, un vero inno AOR dove le tastiere di Tommy Rude brillano in primo piano. “I Believe in You” è un iconico esempio di AOR di alta scuola, con un sound che richiama band storiche come Journey e Foreigner. La ballata dell’album, “Save A Place In Your Heart”, è un momento di grande ed intima emozione: raffinata e intensa, è dominata dalle tastiere e dalla voce appassionata di Sabu.
“Only Child” è stato elogiato per la sua coerenza e per l’alta qualità delle composizioni. È considerato superiore persino a *Heartbreak*, il precedente album solista di Sabu. Nonostante non abbia raggiunto il successo commerciale di altri album AOR dell’epoca (anche a causa della distribuzione limitata sotto Rampage, una sottodivisione della già poco nota Rhino Records), l’album ha però conquistato il rispetto degli appassionati, guadagnandosi lo status di oggetto di culto.
Il sound dell’album richiama l’energia, la potenza e il coinvolgimento delle migliori colonne sonore dei film d’azione degli anni ’80. Considerando che Sabu ha spesso prestato il suo talento a colonne sonore di film più o meno noti, questa associazione appare perfettamente naturale.
Stiamo dunque parlando di un album imprescindibile per ogni amante dell’AOR, un capolavoro che incarna lo spirito degli anni ’80 e che, nonostante il tempo, continua a risuonare con la stessa forza e autenticità di allora.
Mr. Mister – Welcome To The Real World – Classico
12 Dicembre 2024 1 Commento Samuele Mannini
genere: Pop Rock/Aor
anno: 1985
etichetta:
ristampe:
Ok, prendiamo la macchina del tempo e torniamo indietro ai miei 12 anni quando il sabato pomeriggio guardavo Discoring sul divano ascoltando tutto ciò che quelli anni magici proponevano… È il novembre 1985, ed i Mr. mister rilasciano “Welcome To The Real World” uno di quei lavori che ha lasciato un’impronta indelebile negli anni ‘80 ed il singolo “Broken Wings” spazza le classifiche di mezzo mondo. Un successo travolgente che ha scalato la Billboard 200 fino al primo posto, conquistando il disco di platino negli Stati Uniti e addirittura il triplo platino in Canada, questo album ha reso la band un simbolo di quel decennio irripetibile.
Il segreto del successo di “Welcome To The Real World” sta nella sua alchimia musicale. Richard Page (voce e basso), Steve George (tastiere e cori), Steve Farris (chitarra e cori) e Pat Mastelotto (batteria) hanno saputo unire con maestria AOR, new wave e pop rock, creando un’esperienza sonora raffinata e coinvolgente. Ogni traccia è un viaggio tra melodie orecchiabili e arrangiamenti elaborati, resi ancora più potenti dalla produzione curatissima.
Rendiamoci conto di che razza di disco sia questo e che canzoni abbia donato al mondo.”Kyrie” è un autentico inno, che combina l’intensità emotiva a un’architettura musicale perfetta, il riff di synth che apre il brano è immediatamente riconoscibile, mentre la chitarra di Farris e la voce di Page si fondono in un crescendo spirituale che trascina chi ascolta in un’esperienza quasi mistica. “Broken Wings” è uno di quei brani che possa vantare la delicatezza e la potenza emotiva degni di una grande ballata, destinata a sfidare il tempo, con un testo che esplora la vulnerabilità dell’amore e una melodia eterea, la canzone è diventata un classico senza tempo, amplificato da un videoclip che è pura poesia, anche visiva. “Black/White” è l’apertura perfetta per l’album, pezzo energico e ricco di arrangiamenti sinfonici che cattura subito l’attenzione, mettendo in evidenza l’abilità dei Mr. Mister di coniugare potenza e raffinatezza. “Uniform of Youth”, è invece una gemma funky che dimostra la versatilità della band, con ritmi complessi, un assolo di chitarra incisivo e melodie di tastiera che catturano al volo. Anche le tracce meno ‘conosciute’ meritano attenzione. “Don’t Slow Down” e “Into My Own Hands” tengono alta l’energia dell’album con un pop rock vibrante e dinamico, mentre “Run to Her”, magari pur non raggiungendo le vette dei singoli principali, aggiunge però un tocco introspettivo, mostrando un lato più riflessivo della band.
L’impatto di questo album fu straordinario, rendendo i Mr. Mister una delle band più riconoscibili del decennio. Tuttavia, il loro successo è stato, seppur clamoroso, fugace. Gli album successivi non hanno saputo replicare la magia di “Welcome To The Real World”, portando poi allo scioglimento della band nel 1990. Questo non è solo un album, ma una finestra aperta su uno dei momenti più luminosi della musica degli anni ‘80. Con brani indimenticabili che hanno definito un’era, la capacità di combinare generi musicali in modo fluido e innovativo ed arrangiamenti e produzione che ai giorni nostri provocano solo sogni erotici, un punto di riferimento per gli amanti del genere e una testimonianza della capacità dei Mr. Mister di trasformare emozioni in musica. Oggi, ascoltarlo significa rivivere un’epoca in cui le melodie erano regine ed ogni nota sembrava avere qualcosa da dire. Un classico che merita di essere celebrato, perché purtroppo la macchina del tempo non può farvi restare lì su quel divano per sempre…
3 – …To The Power Of Three – Gemma Sepolta
05 Dicembre 2024 9 Commenti Samuele Mannini
genere: AOR/Prog
anno: 1988
etichetta:
ristampe:
Nel 1988, il progressive rock era un lontano ricordo degli anni ’70, soppiantato da sonorità più accessibili e commerciali come il pop rock e l’AOR. In questo contesto, due pilastri del prog, Keith Emerson e Carl Palmer, si uniscono a Robert Berry, polistrumentista americano di grande talento, per formare il supergruppo 3. Il loro unico album, To the Power of Three, rappresenta una chiara svolta rispetto al passato: un lavoro radicato nel sound radiofonico dell’AOR, con qualche strizzata d’occhio alle loro origini prog.
L’album si posiziona in un territorio pericoloso, cercando di bilanciare due mondi diversi. Le sonorità ambiziose degli Emerson, Lake & Palmer vengono semplificate, adattandosi ai canoni di un’epoca che privilegiava melodia e immediatezza. Questo cambiamento ha generato reazioni contrastanti: la critica lo ha accolto freddamente, lamentando la distanza dai fasti di capolavori come Tarkus o Brain Salad Surgery, mentre il pubblico, poco interessato al pedigree progressive dei musicisti, non ha premiato l’album, che ha raggiunto solo il 97° posto nella Billboard 200. Ma il vero quesito è un altro: ‘To the Power of Three’ è davvero un passo falso?
Pur abbracciando sonorità AOR tipiche di band come Asia o Journey, l’album conserva elementi che richiamano l’eredità musicale dei protagonisti. Robert Berry, autore principale, dimostra grande versatilità: la sua voce calda e potente si adatta perfettamente al genere, e la sua abilità come compositore emerge in brani orecchiabili e ben costruiti. In tracce come “Talkin’ Bout”, il singolo che ha raggiunto la top 10 della classifica Mainstream Rock di Billboard, Berry sfodera un ritornello irresistibile e un sound immediato, confermando il suo talento. Keith Emerson, pur defilato rispetto al passato, impreziosisce le tracce con arrangiamenti ricercati. I suoi sintetizzatori conferiscono profondità e colore, spingendo i confini dell’AOR verso territori più raffinati, come dimostrano le atmosfere complesse di “Desde La Vida”, una suite in tre parti che è il cuore prog dell’album. Infine, Carl Palmer, forte dell’esperienza con gli Asia, conferma di saper integrare il suo stile tecnico in un contesto più commerciale, senza sacrificare la precisione e l’energia che lo caratterizzano. La sua batteria, sempre potente e impeccabile, fornisce una solida base ritmica, sostenendo le melodie senza mai risultare invasiva. Ed infine vorrei citare anche “On My Way Home”, una ballata emozionante, che regala un tocco epico e nostalgico. Può essere discutibile la versione di ‘Eight Miles High’, la band ha infatti optato per una rielaborazione riscrivendo anche parte del testo del brano dei Byrds, con un risultato che va lasciato al giudizio personale.
In sostanza ‘To the Power of Three’ non è stato probabilmente l’album che i fan degli Emerson, Lake & Palmer speravano, ma non per questo merita di essere liquidato come un errore di percorso. È un lavoro ben prodotto e interpretato, che riflette il tentativo sincero di adattarsi ai gusti dell’epoca senza però abbandonare del tutto la propria identità artistica. Con una maggiore attenzione promozionale da parte della Geffen Records ed un pizzico di fortuna in più, questo disco avrebbe potuto aprire la strada ad un secondo capitolo per i 3. È rimasto invece un’opera, forse incompresa, che attende solo di essere rivalutata da un pubblico più aperto alle contaminazioni tra prog e AOR ed a tal proposito nel 2018 e nel 2021 sono usciti due dischi a nome 3.2 dove Robert Barry tenta di riprendere l’esperimento lì dove era stato interrotto. Da riscoprire.
1927 – …ish – Gemma Sepolta
01 Dicembre 2024 0 Commenti Samuele Mannini
genere: Pop Rock/Aor
anno: 1988
etichetta:
ristampe:
Nel 1988, i 1927 debuttarono con …ish, un album che, con oltre 400.000 copie vendute e due ARIA Awards in bacheca, catapultò la band agli onori della scena rock australiana, donando al gruppo quel po’ di fama per varcare i confini nazionali e far giungere anche dalle nostre parti un disco (anzi due, perché anche il seguente “The Other Side” è meritevole) che sinceramente non dovreste sottovalutare.
Ho scoperto questa band proprio grazie al loro secondo lavoro, “The Other Side”, acquistato approfittando delle offerte di CD “forati” a 3900 lire su Sweet Music. Questo mi spinse a cercare anche il loro album di debutto, e fin dalle prime note mi fu chiaro che …ish non era semplicemente un altro album pop rock degli anni ’80.
Il loro album si apre con “To Love Me“, una traccia esemplificativa del pop rock australiano anni ’80, che imposta perfettamente il tono del disco. Segue ‘That’s When I Think of You’, un singolo di successo dal ritmo accattivante, impreziosito da un raffinato assolo di chitarra. La ballata rock “If I Could” si distingue per la sua intensità emotiva. Proseguiamo con “Compulsory Hero”, uno dei pezzi più iconici della band, vincitore dell’ARIA Award per il Miglior Video nel 1990, un racconto epico sui temi del sacrificio e della speranza, del quale abbiamo parlato ampiamente nella nostra sezione dedicata alle power ballads (LINK). Infine, la vivace e dinamica “You’ll Never Know” chiude una prima parte dell’album di grande impatto.
La seconda parte dell’album inizia con “All The People”, un solido pezzo pop/rock che, pur non raggiungendo le vette delle precedenti canzoni, si integra armoniosamente nell’album. “Nothing In The Universe” offre un’esperienza d’ascolto piacevole e rilassante, mentre “Propaganda Machine” sperimenta con un mix interessante di electro punk e pop, aggiungendo varietà al disco. “Give The Kid A Break” infonde energia con i suoi riff di chitarra e il ritmo coinvolgente, preparando il terreno per la chiusura con “The Mess”, che onestamente pur non lasciando il segno mantiene comunque una coerenza sonora con le altre tracce.
Se ascolterete il disco vi salteranno subito alle orecchie svariate assonanze col sound di diverse band pop rock melodiche di quell’epoca quali: Boulevard, Mr. Mister e Glass Tiger. Il cantante Eric Weideman ha una vocalità morbida ed espressiva e ci culla con le sue armonie per tutto il disco. Il songwriting dell’album, in gran parte opera del chitarrista Gary Frost, ha la capacità di creare immagini vivide e raccontare storie evocative punteggiate poi efficacemente e con gusto nell’esecuzione.
Se anche a più di trent’anni dopo la sua uscita, …ish è considerato in patria un punto di riferimento, ci sarà dunque un perché. L’album riesce infatti a catturare l’essenza del periodo in cui è stato prodotto e contiene tutte le virtù del pop rock nel suo periodo di massima espressione. Con i suoi numerosi pregi ed al netto di qualche imperfezione, …ish è un debutto significativo che vi consiglio caldamente di ascoltare, scoprire o riscoprire.
Quireboys – A Bit Of What You Fancy – Classico
28 Novembre 2024 3 Commenti Samuele Mannini
genere: Hard Rock
anno: 1990
etichetta:
ristampe:
Nel 1990, i Quireboys fecero un’entrata trionfale nel panorama musicale con il loro album di debutto, “A Bit Of What You Fancy”. Questo lavoro rappresenta una miscela esplosiva di rock’n’roll autentico e blues vibrante, riuscendo a raggiungere la seconda posizione nelle classifiche britanniche e a consolidare la band come un astro nascente da non sottovalutare nel mondo del rock d’oltremanica.
“A Bit Of What You Fancy” trasporta l’ascoltatore in un viaggio musicale attraverso i fumosi club rock d’altri tempi, dove le chitarre ruggivano, le note di piano scintillavano e la voce graffiante di Spike intratteneva il pubblico come solo un vero frontman sa fare, evocando la vera epoca d’oro del rock. I critici hanno spesso paragonato il sound dei Quireboys a quello di una versione più ruvida dei Faces, con chiari richiami ai Rolling Stones del periodo aureo, ma anche chi adora i Cinderella più bluesegianti trova qui pane per i suoi denti… L’armonica e il piano, sapientemente suonati da Chris Johnstone, aggiungono un tocco raffinato e complesso al sound della band, creando un’atmosfera ricca e multiforme, andando oltre al ‘semplice’ brano di rock’n’roll. Le chitarre di Guy Bailey e Guy Griffin si fondono in riff potenti e melodie avvincenti, mentre la solida sezione ritmica sostiene le acrobazie vocali di uno Spike che sembra la versione scatenata di Rod Stewart.
L’album è costellato di brani memorabili che sono diventati veri inni per i fan. “7 O’Clock”, con la sua energia esplosiva e l’atmosfera festosa, incarna perfettamente lo spirito dei Quireboys. “Hey You”, altro singolo di successo, è un inno rock irresistibile che si imprime subito nella mente. Tuttavia, “A Bit Of What You Fancy” non è solo un album energico, festoso e goliardico. Brani come “Whippin’ Boy” rivelano il lato più blues e introspettivo della band. L’atmosfera cupa e malinconica, arricchita da cori femminili, crea un contrasto intrigante con i pezzi più vivaci. “Roses & Rings”, con le sue sfumature vicine al country, dimostra la versatilità dei Quireboys e la capacità di Spike di adattarsi a stili diversi. Come non menzionare poi la triste ballad “I Don’t Love You Anymore”, il cui video ho visto passare a ripetizione sull’ allora Videomusic… quanti ricordi…
A oltre trent’anni dalla sua pubblicazione, “A Bit Of What You Fancy” continua ad essere una pietra miliare nella storia del rock britannico. Le sue sonorità autentiche e potenti, unite alla capacità dei Quireboys di creare brani che lasciano il segno, hanno lasciato una traccia profonda nella memoria di noi appassionati del genere. Che è da avere per forza neanche ve lo devo dire.










