LOGIN UTENTE
Registrati a MelodicRock.it

Registrati gratuitamente a Melodicrock.it! Potrai commentare le news e le recensioni, metterti in contatto con gli altri utenti del sito e sfruttare tutte le potenzialità della tua area personale.
effettua il Login con il tuo utente e password oppure registrati al sito di Melodic Rock Italia!
Recensione
- Home
- /
- Ultime Recensioni
- /
- Crowne – Kings In The North – Recensione
Crowne – Kings In The North – Recensione
16 Giugno 2021 8 Commenti Vittorio Mortara
genere: Hard Rock
anno: 2021
etichetta: Frontiers
Tracklist:
01. Kings In The North
02. Perceval
03. Sharoline
04. Unbreakable
05. Mad World
06. One In A Million
07. Sum Of All Fears
08. Set Me Free
09. Make A Stand
10. Cross To Bear
11. Save Me From Myself
Formazione:
Alexander Strandell – Voce
Jona Tee – Chitarre, tastier e cori
John Levén - Basso
Christian “Kicken” Lundqvist – Batteria
Ospiti:
Love Magnusson – chitarra solista
C’era una volta, in un epoca non molto lontana, un mondo ideale, in cui il metal, l’hard rock e l’AOR erano generi “commerciali” e vendevano milioni di dischi. Le band si chiudevano in studio per mesi, a confrontare ed amalgamare le idee di tutti i membri, per partorire poi un album che veniva registrato sotto l’egida di produttori fenomenali con a disposizione budget stellari. L’album veniva poi commercializzato e promosso con lunghi tour internazionali che potevano anche durare anni, durante i quali milioni di fans di tutto il mondo potevano ascoltare i loro beniamini. E questi ultimi potevano suonare il proprio repertorio insieme per centinaia di volte, migliorando l’amalgama del gruppo e potendo contemporaneamente toccare con mano la reazione del proprio pubblico. In quel tempo i supergruppi si chiamavano Bad English, Mr. Big, Damn Yankees… Erano veramente super, ma, soprattutto, erano veramente gruppi! Rimanevano insieme a pubblicare album dopo album e a fare tour dopo tour. Per anni. Poi vennero il grunge, il rap, il trap e mille altri generi ad affollare le classifiche. La nostra musica venne ghettizzata e mantenuta in vita da poche etichette specializzate al servizio di un ristretto manipolo di inossidabili estimatori. I concerti divennero quasi in organizzabili perché i costi non venivano coperti dagli incassi dei pochi biglietti venduti, e le bands si trovavano a registrare albums con pochi mezzi e pochi soldi da investire. In questa nuova situazione nacque anche una nuova idea di supergruppo, cioè la collaborazione di musicisti più o meno famosi facenti parte di bands più o meno “di grido” che decidono più o meno autonomamente di suonare e registrare qualche pezzo insieme, anche senza necessariamente essere ispirati da un comune desiderio di voler provare o sperimentare qualcosa di alternativo alle rispettive band madri.
Mi scuso per il lungo pistolotto di introduzione, ma mi è assolutamente necessario per spiegarvi perché a me questi Crowne sono piaciuti poco.
Nati da un’idea del nostro Serafino Perugino, i Crowne sono Alexander Strandell (Art Of Nation), Jona Tee (H.E.A.T.), John Levén (Europe), Christian Lundqvist (The Poodles) e l’ospite Love Magnusson (Dynazty). Sono tutti svedesi, hanno tutti un’ottima padronanza del proprio strumento ed hanno tutti alle spalle diversi anni di esperienza. La produzione, affidata a Tee, risulta potente e pulita, ai massimi livelli ascoltabili nel genere al giorno d’oggi. Perché, dunque, non siamo di fronte ad un disco memorabile? Ad un capolavoro dei nostri tempi? Beh, a giudizio di chi vi scrive, i fattori sono molti. Per la maggior parte del lavoro, intanto, viene proposta una sorta di Hard/AOR sullo stile degli ultimi album di Eclipse, H.E.A.T. e Vega, ma con un’enfasi maggiore sull’epicità del sound, dal rifferama piuttosto duro, in cui gli up-tempo la fanno da padroni, tanto da sconfinare talvolta nel power più melodico. La voce di Strandell, pur stentorea e pulita, indugia un po’ troppo spesso sui toni alti. Il tutto genera una certa sensazione di monotonia e monoliticità. A questo aggiungerei che non esiste un pezzo trainante, una canzone che spacca e che ti ritrovi a canticchiare durante tutto il giorno. Alla fine dell’ascolto hai addosso quella sensazione di avere per le mani un buon disco. Ma ti senti anche insoddisfatto. Come se mancasse qualcosa. E quel qualcosa è l’anima. La parte più emozionale. L’ispirazione. Manca anche quella botta di adrenalina che ti aspetteresti dal versante più hard del nostro genere. Quella, per intenderci, che ti arriva dritta sugli incisivi quando ascolti l’ultimo dei Temple Balls. Infine manca anche quasi del tutto l’originalità. E non fatemi parlare del look dei nostri, a metà fra gli Immortal ed i protagonisti del Trono di spade…
Volendo disaminare i vari brani, si comincia con “Kings in the north”, pezzo molto hard, cadenzato, epico e non molto convincente a livello di melodia, bissato dall’up-tempo in doppia cassa “Perceval”, il refrain del quale tende al grandioso più che alla facile presa. Sempre su ritmi sostenuti e riff spiccatamente metal si fonda “Sharoline”, stavolta dotata di un coro più catchy e di un ottimo lavoro della solista. “Unbreakable” frena leggermente e, nonostante tutta la band faccia egregiamente il suo lavoro, alla fine non riesce a graffiare. Partenza a rullo compressore con tanto di sirene della polizia per “Mad world”, di certo più interessante per la strofa molto atmosferica ed il gradevole riff zoppo sotto il bel coro. “One in a million” è smaccatamente eclipsosa in tutti i suoi frangenti, motivo per il quale suona troppo come già sentita. Ancora la doppia cassa lancia la metallizzata “Sum of all fears”, molto più vicina ad Axxis ed Hellowenn che a Journey e Night Ranger, ma abbastanza piacevole, in fin dei conti, anche per lo splendido assolo neoclassico. Arrivati al brano numero 8, “Set me free”, ci si imbatte nel mio pezzo preferito. Grazie a Dio una canzone melodica, fortemente contaminata dal pop nordeuropeo contemporaneo, strutturata alla perfezione, sulla quale la splendida voce di Alexander può sfoderare una prestazione maiuscola, accompagnata in modo adeguato dall’intera band. Purtroppo il livello torna decisamente più basso con il mid tempo “Make a stand”, tristemente povero di spunti. Di impostazione simile, ma un po’ più centrata, “Cross to bear”, per lo meno grazie al chorus anthemico. E si chiude con “Save me from myself”, un lento, che sintetizza perfettamente l’intero lavoro: non si tratta di una brutta canzone, anzi, ma lascia quel senso di potenzialità inespressa che ti impedisce di ritenerti soddisfatto.
Insomma, a mio parere le grandi aspettative che si sono create intorno a questo album si sono rivelate quasi totalmente infondate. Ripeto, il lavoro non è brutto, né suonato male e nemmeno si può dire abbia una produzione scadente. Però la scarsa creatività a livello compositivo, l’impatto emozionale piuttosto povero e la sensazione di una ennesimo supergruppo creato a tavolino fanno sì che l’ascolto non impressioni come dovrebbe l’ascoltatore, andando a fare compagnia alle ultime realizzazioni di grossi nomi (i già citati H.E.A.T., Eclipse e Vega) in quella zona del cervello più vicina al dimenticatoio… Peccato.
© 2021, Vittorio Mortara. All rights reserved.

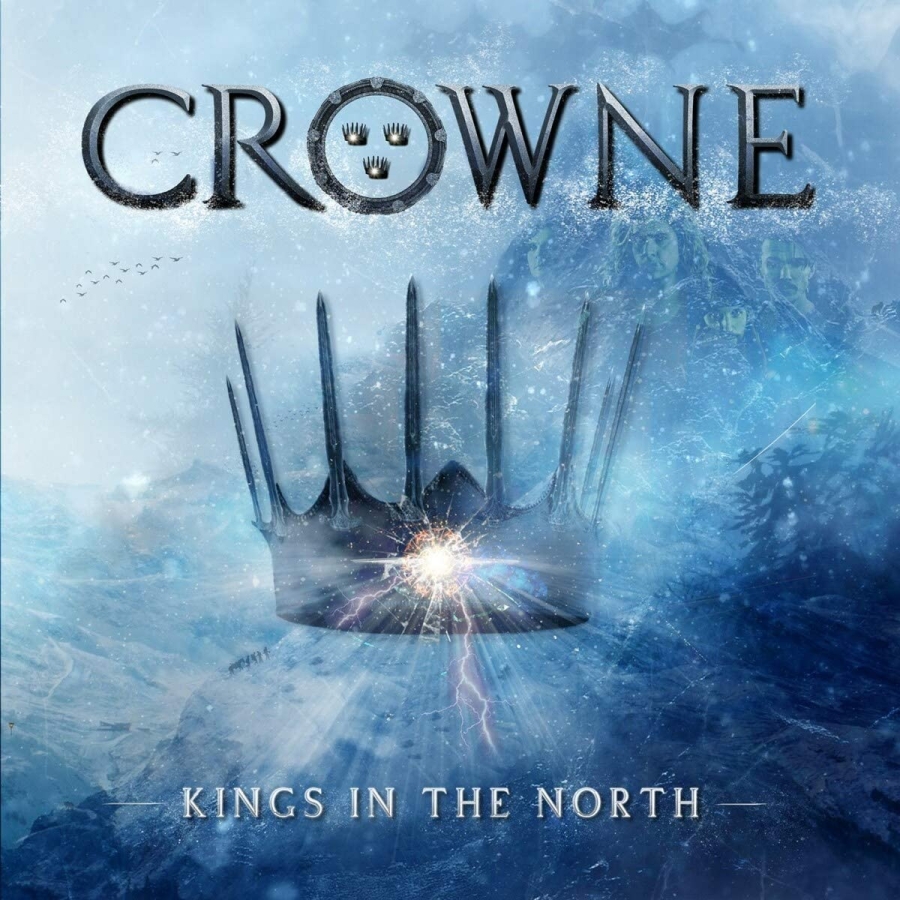







Devi essere registrato e loggato sul sito per poter leggere o commentare gli Articoli